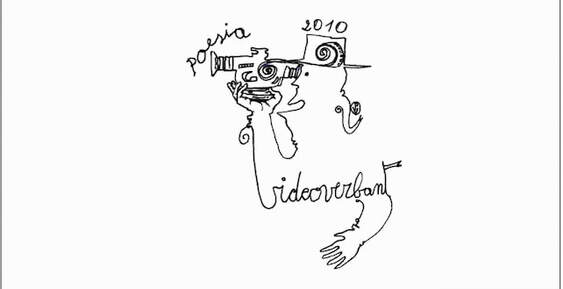STORIA DEL CINEMA
Ragazze d'oggi 1955 di Luigi Zampa
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=-5L0wSFIaF8&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt
Il titolo ci indurrebbe ad aspettarci un film leggero e invece il tema della crescita morale nelle tentazioni del denaro che tutto corrompe è sviluppato con un equilibrato e impegnativo narrare; le belle ragazze in età da marito sono il fulcro del racconto con delle protagoniste assai credibili nella recitazione e nella scena. Onestà non è contrapposta a disonestà come unico tema ma piuttosto a immaturità, vita facile incoscienza, e, solo in un caso, in progetto di corruzione e di sfruttamento criminale, come nell'episodio della pensione di avviamento alla prostituzione. Le protagoniste hanno tutte una grande freschezza di recitazione; profondamente calati nei personaggi sia la zia che il padre, Paolo Stoppa, davvero bravo, con una varietà fisiognomica notevole. Il tema delle ragazze da marito è molto frequentato nella letteratura dalle origini fino al nostro novecento, ma qui possiamo dire che alla soglia degli anni 60 è raccontato come un residuo della vecchia famiglia oggi lentamente superato dall'emancipazione delle donne riguardo alle loro scelte. E ciononostante quell'emancipazione costa cara, è un impegno morale e si raggiunge solo con equilibrato comportamento ma soprattutto aiutati dall'affetto e dall'esperienza dei nostri cari più vicini: i genitori. L'insidia del facile successo o del facile guadagno e anche della scalata sociale potrebbe portare a dare un prezzo ai sentimenti e all'amore. C'è sempre chi ingannando giovani vite al loro sbocciare e inesperte ne approfitta costruendogli una trappola di perdizione. L'apertura con una panoramica sulla darsena del Naviglio di Milano vuole collocare il territorio per radicarne sociologicamente il racconto più volte confermato con battute dei personaggi sui costumi tra nord e sud. Il padre delle ragazze dirà che è di Napoli, la cognata marcherà molte volte questa sua provenienza come una fragilità anzi un impedimento sociale al successo. Il colore della fotografia è di un pastello molto interessante che rende assai fruibili le sequenze. Il film non ha particolari momenti erotici, le cui situazioni narrative vengono sottintese e rese impliciti con gli stacchi, probabilmente per rendere popolare la visibilità senza dover incorrere in particolari censure. Eppure trovo molto interessante il segnale dei temi del racconto: il corpo femminile la sessualità e il matrimonio sociale con quella sequenza sui reggicalze che le sorelle si girano perché ne posseggono uno solo e Sofia lo scopre ad Anna alzandole la gonna di sorpresa, ecco direi che il punto di concentrazione erotica di tutto il film stia genialmente in quella sequenza anticipatrice. Eppure i baci che seguiranno sono tutti molto casti collocando così le tre sorelle in un profilo di sprovvedute più che ragazze leggere. I temi dell'autonomia sociale ed economica per le donne nella società italiana si svilupperanno nelle successive riprese, inquadrature strette, d'interno familiari con le considerazioni di Sandro, un imprevedibile Mike Buongiorno, steward di volo, portatore delle informazioni sulla vita delle ragazze americane che si sono conquistate una dignità e indipendenza con il lavoro e l'autonomia sociale. Molto roseo il finale; tutte le sorelle si salvano dalla perdizione e non perché ci sia stato un sofferto processo di presa di coscienza piuttosto in quanto istintivamente risolute ad uscirne e neanche per particolare intromissione paterna. Si lascia credere che sia stato il fidanzato di Anna ad aver avviato il processo critico e che la ragazza non solo si rifiuterà di concedersi prima del matrimonio ma sarà lei con Sandro a prendere il volo prima delle altre. E con questa immagine del "volo", simbolica e la battuta del padre a Sofia "dopo ti devo parlare" e la rassicurazione delle sorelle maggiori alla sorella minore di aiutarla ad aspirare a una felicità possibile nel matrimonio si chiude con un campo lungo la scena ben simboleggiando con una sola inquadratura la narrazione di una prospettiva, di un futuro per tutte le ragazze.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=-5L0wSFIaF8&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt
Il titolo ci indurrebbe ad aspettarci un film leggero e invece il tema della crescita morale nelle tentazioni del denaro che tutto corrompe è sviluppato con un equilibrato e impegnativo narrare; le belle ragazze in età da marito sono il fulcro del racconto con delle protagoniste assai credibili nella recitazione e nella scena. Onestà non è contrapposta a disonestà come unico tema ma piuttosto a immaturità, vita facile incoscienza, e, solo in un caso, in progetto di corruzione e di sfruttamento criminale, come nell'episodio della pensione di avviamento alla prostituzione. Le protagoniste hanno tutte una grande freschezza di recitazione; profondamente calati nei personaggi sia la zia che il padre, Paolo Stoppa, davvero bravo, con una varietà fisiognomica notevole. Il tema delle ragazze da marito è molto frequentato nella letteratura dalle origini fino al nostro novecento, ma qui possiamo dire che alla soglia degli anni 60 è raccontato come un residuo della vecchia famiglia oggi lentamente superato dall'emancipazione delle donne riguardo alle loro scelte. E ciononostante quell'emancipazione costa cara, è un impegno morale e si raggiunge solo con equilibrato comportamento ma soprattutto aiutati dall'affetto e dall'esperienza dei nostri cari più vicini: i genitori. L'insidia del facile successo o del facile guadagno e anche della scalata sociale potrebbe portare a dare un prezzo ai sentimenti e all'amore. C'è sempre chi ingannando giovani vite al loro sbocciare e inesperte ne approfitta costruendogli una trappola di perdizione. L'apertura con una panoramica sulla darsena del Naviglio di Milano vuole collocare il territorio per radicarne sociologicamente il racconto più volte confermato con battute dei personaggi sui costumi tra nord e sud. Il padre delle ragazze dirà che è di Napoli, la cognata marcherà molte volte questa sua provenienza come una fragilità anzi un impedimento sociale al successo. Il colore della fotografia è di un pastello molto interessante che rende assai fruibili le sequenze. Il film non ha particolari momenti erotici, le cui situazioni narrative vengono sottintese e rese impliciti con gli stacchi, probabilmente per rendere popolare la visibilità senza dover incorrere in particolari censure. Eppure trovo molto interessante il segnale dei temi del racconto: il corpo femminile la sessualità e il matrimonio sociale con quella sequenza sui reggicalze che le sorelle si girano perché ne posseggono uno solo e Sofia lo scopre ad Anna alzandole la gonna di sorpresa, ecco direi che il punto di concentrazione erotica di tutto il film stia genialmente in quella sequenza anticipatrice. Eppure i baci che seguiranno sono tutti molto casti collocando così le tre sorelle in un profilo di sprovvedute più che ragazze leggere. I temi dell'autonomia sociale ed economica per le donne nella società italiana si svilupperanno nelle successive riprese, inquadrature strette, d'interno familiari con le considerazioni di Sandro, un imprevedibile Mike Buongiorno, steward di volo, portatore delle informazioni sulla vita delle ragazze americane che si sono conquistate una dignità e indipendenza con il lavoro e l'autonomia sociale. Molto roseo il finale; tutte le sorelle si salvano dalla perdizione e non perché ci sia stato un sofferto processo di presa di coscienza piuttosto in quanto istintivamente risolute ad uscirne e neanche per particolare intromissione paterna. Si lascia credere che sia stato il fidanzato di Anna ad aver avviato il processo critico e che la ragazza non solo si rifiuterà di concedersi prima del matrimonio ma sarà lei con Sandro a prendere il volo prima delle altre. E con questa immagine del "volo", simbolica e la battuta del padre a Sofia "dopo ti devo parlare" e la rassicurazione delle sorelle maggiori alla sorella minore di aiutarla ad aspirare a una felicità possibile nel matrimonio si chiude con un campo lungo la scena ben simboleggiando con una sola inquadratura la narrazione di una prospettiva, di un futuro per tutte le ragazze.
Il piccolo vetraio 1955 di Giorgio Capitani
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=v2nUClv-2Es&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=3
si, il tema e il soggetto costituiscono una bella prova di narrazione, peccato che nel linguaggio del cinema questa prova sia stata indebolita da qualche buco di sceneggiatura e certi inciampi nel ritmo. La verosimiglianza così entrava in dubbio e il genere perdeva la sua certezza di impostazione e scelta che diviene stile. Pregevoli alcune inquadrature di primi piani ( ce ne sarebbero dovuto essere molti di più per drammatizzare il contesto presentato. Anche alcuni campi lunghi come quello sulla riva del fiume erano belli, promesse di un seguito di stile che purtroppo inciampava in una narrazione a tratti didascalica eccessivamente mostrata. Bravo il protagonista come i suoi genitori nonostante il breve tempo di apparizione. Poco convincente il loro aguzzino non sufficientemente caratterizzato, non quanto la vecchia. Certo il racconto in sé tocca l'animo ma quella è letteratura, nel cinema sono le inquadrature che fanno la drammatizzazione del racconto; e qui ce ne erano di possibilità di stringere il campo proprio per esaltarlo. Dello sfruttamento dei ragazzi c'è poca traccia visiva eppure quello doveva essere il suo centro. Non lo avevo mai visto; l'ho guardato con interesse.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=v2nUClv-2Es&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=3
si, il tema e il soggetto costituiscono una bella prova di narrazione, peccato che nel linguaggio del cinema questa prova sia stata indebolita da qualche buco di sceneggiatura e certi inciampi nel ritmo. La verosimiglianza così entrava in dubbio e il genere perdeva la sua certezza di impostazione e scelta che diviene stile. Pregevoli alcune inquadrature di primi piani ( ce ne sarebbero dovuto essere molti di più per drammatizzare il contesto presentato. Anche alcuni campi lunghi come quello sulla riva del fiume erano belli, promesse di un seguito di stile che purtroppo inciampava in una narrazione a tratti didascalica eccessivamente mostrata. Bravo il protagonista come i suoi genitori nonostante il breve tempo di apparizione. Poco convincente il loro aguzzino non sufficientemente caratterizzato, non quanto la vecchia. Certo il racconto in sé tocca l'animo ma quella è letteratura, nel cinema sono le inquadrature che fanno la drammatizzazione del racconto; e qui ce ne erano di possibilità di stringere il campo proprio per esaltarlo. Dello sfruttamento dei ragazzi c'è poca traccia visiva eppure quello doveva essere il suo centro. Non lo avevo mai visto; l'ho guardato con interesse.
La Presidentessa 1952 di Pietro Germi
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=St6rrJKjr6o
Godibilissimo esordio della Commedia all’Italiana con un cast di attori di grande talento.
Silvana Pampanini, Ave Ninchi, Carlo Dapporto, Ernesto Calindri, Aroldo Tieri, tutti capaci di infondere al film una leggerezza recitativa e allo stesso tempo una sapienza scenica degna della tradizione del cinema muto nei suoi soggetti più ricchi di scambi e travestimenti.
È il teatro nel cinema e il cinema nel teatro che ci viene offerto fin dalla prima inquadratura del cabaret-avanspettacolo in cui la soubrette Gobette si esibisce acclamata da un pubblico che le fa da coro. La Pampanini è capace di diffondere una sensualità tutta italiana che pur negli accenti ironici mantiene quel candore e gioco della vita piena di promesse e di desiderio senza alcun fine negativo né moralistico.
Ecco il messaggio che ci sembra venire dall’intero film; un bonario invito a divertirsi quando, nel caotico imprevedibile destino, ci capita di partecipare all’intreccio di equivoci e sottintesi, anche se il nostro ruolo sociale ne dovrebbe esprimere la più integra condotta dalle tentazioni. Se tutto un Ministero, e più precisamente gli uomini che ne compongono le gerarchie dei ruoli, viene coinvolto in un serie di seduzioni dal femminile è perché questi “benpensanti borghesi” si servono della menzogna per raggiungere i loro fini di potere in qualunque contesto e a qualunque costo. Ma tutto questo narrare ci viene proposto nella forma della parodia e in un certo senso con i riferimenti alla commedia dell’arte, almeno per ciò che riguarda gli scambi di persona e gli intrecci amorosi.
Germi riesce a sviluppare una sequenza ritmica, fatta di splendidi piani fotografici, raccogliendo dai volti dei personaggi quella mimica che li trasforma in stereotipi di profili sociali e professionali. Le inquadrature scorrono in piani medi e primi piani sottolineati da un motivetto d’accompagnamento del pianoforte che rievoca fortemente il muto delle origini, non una colonna sonora ma temi e accenti canori che sostengono le continue sorprese dell’intreccio denso di battute comiche e per quei tempi fulminanti.
La storia è ambientata agli inizi del novecento, per rendere più credibile l’adulterio in quel mondo sociale e la morale di una integrità anche professionale, se pur celibi, come si intuisce per il Ministro, e il primo sedotto dalla Gobette, l’ispettore.
Il lieto fine emergerà nell’amore che governa su tutti ignorando i ruoli sociali e le finte austerità scoccando i suoi dardi a ricomporre le coppie nel loro più naturale assortimento.
Così sarà per il Ministro e la Gobette, il Presidente e la Presidentessa fino all’attendente con la giovane figlia dei Tricoin.
L’albergo e gli interni del Ministero del palcoscenico e dell’abitazione del Presidente sono i sobri set finti, come lo è il palcoscenico del teatro nelle sue allusioni e inseguimenti della vita reale; qui eletta a parabola dell’amore dispensato da una donna socialmente discutibile nella scala dei valori morali, eppure la più generosa e sensibile del gruppo. Tanto che anche le performance delle sue seduzioni ci risultano una generosità, una volontà benevola di concedere le sue “Grazie” piuttosto che di tessere malefici tranelli e scandali. Lei è così per natura, distante dalla morbosità moralistica degli uomini di potere che fingono una austerità e una indifferenza ostentata.
Dalla piccola città di Gray scelta per l’ambientazione di una commedia francese Germi trae un rocambolesco meccanismo di capovolgimenti con azioni che pur audaci non finiscono mai di stupirci né mai cadono nel gratuito. La commedia è serrata e l’affiatamento tra gli attori rende credibile la vicenda benché esposta in un tono molto teatrale, sia nel ritmo che nell’atmosfera. La nudità femminile su cui si gioca l’intreccio, se pure in mutandoni e guepiere ci sorprende a prendere atto dei due opposti sentimenti il grottesco e il desiderabile; entrambe le protagoniste conducono il gioco inseguite da uomini poco credibili da attributi maschili più ostentati a parole che reali; è la commedia umana dell’ipocrisia borghese e provinciale.
La peccatrice 1940 di Amleto Palermi
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=jTHEPiqF4sI&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=4
Un esercizio di cinema riuscitissimo, gli attori tutti calati nello loro parte credibili come personaggi di una storia italiana fortemente di costume sociale e morale. Un soggetto che ci provoca rabbia e nostalgia. La prima per la violenza nei confronti delle donne e la seconda per un mondo che non può più esistere, in cui gli uomini vivevano nel paesaggio di una natura ciclica, anche se la sceneggiatura di questa parabola del "figlio prodigo" cristiana non ci nasconde la crisi proprio di quella comunità di valori dalle insidie di un nascente mondo urbano nel sottofondo del testo. Le inquadrature sono un saggio di cinema e spiccano; la prima, di apertura, sui primi piani delle donne al Bar della casa di appuntamenti, la scala della fuga dalla casa materna, l'attraversamento del ponte sulla bruma e il totale di Maria che si staglia contro il cielo in campagna presso i suoi salvatori. Tante le vicende e le sofferenza di una giovane, che abbandonata, diventa preda dei più vili ricattatori oltre che bersaglio della viltà maschile. I campi lunghi della campagna, i totali e i primi piani ben scelti nel ritmo della narrazione escono dal sentimentalismo e riescono quasi a conferire alla storia un possibile tono epico. Non rinunzia, il regista a una vene dialettica dell'autocritica sociale e di costume dando a Pietro, il giovane fidanzato, incontrato dopo la maternità e perdita del bambino, un momento di coscienza critica di domanda sulla dignità umana e di senso di colpa meritato quando insistente nel pregiudizio, ma soprattutto di corresponsabilità delle azioni umane intraprese da ciascun appartenente alla comunità, se vogliamo chiamarla tale. Il bianco e nero è morbido nella fotografia e ciononostante sottende in certi momenti una lezione espressionista, di luci reali, senza intensificazioni di scena. Si passano i diversi livelli di grigi per arrivare nello scorrere di una sequenza al nero totale dell'intera inquadratura e perciò lo schermo finestra della proiezione acquista un valore simbolico: il nero non del peccato ma della risposta sociale e umana al dramma di una giovane donna ingannata e umiliata. L'intero soggetto svolto con una sceneggiatura accurata eppure sobria risente di una necessità di uno sguardo letterario e forse in più punti anche di un ritmo letterario, ma tutto è molto naturale e spontaneo e seppure non ci sono rilevanti sorprese lungo la durata del film, o almeno non così imprevedibili dopo le premesse di apertura, alcuni passaggi temporali riescono a sviluppare la dinamica dialettica delle coscienze fino all'amore, prima di ogni coscienza, fatto di corpo, che dà vita e protegge altro corpo come quello della madre; è in questa esperienza della maternità vissuta data e ricevuta che Maria ritrova la forza di chiedere accoglienza, giudizio ma soprattutto amore, quell'amore che gli uomini hanno utilizzato per ingannarla, umiliarla, sfruttarla, violentarla. Nei movimenti di macchina, mimetici e solo in alcune scene accennati, sottolineano il punto di osservazione della storia come se leggessimo una lettera e questa voce è di Maria, la protagonista, i cui primi piani rendono pienamente la mimica dei sentimenti la variabilità delle situazioni. I dialoghi sono precisi e seguibili come la colonna sonora, seppure priva di motivi ricorrenti, di temi, come accade oggi, è ben amalgamata con lo sviluppo delle vicende, senza ridondanze o effettismi. Il cinema delle nostre origini matura la sua parabola in queste pellicole dignitosissime che sono state lavorate agli esordi del centro sperimentale per la cinematografia e così cresce l'insegnamento e la critica del linguaggio di un'arte che aveva pochi decenni di storia; è meritevole il coinvolgimento degli allievi con i maestri, Barbaro, Chiarini, Pasinetti come Palermi; essi sono quel fondamento che ha permesso il nostro cinema realista di dettare la nuova semplicità e soprattutto autenticità di narrare storie visive e sonore. Oggi dobbiamo prendere lezione da questi maestri. I nuovi canoni estetici saranno accennati dalla lezione del cinema italiano sia muto che sonoro, ricordiamo solo Assunta Spina, cult movie della cinematografia mondiale. Il feedback su cui è costruita la storia è molto spontaneo, pertinente ed efficacemente risolutivo in senso stilistico, conferisce a Paola Barbara la centralità della conduzione in soggettiva che lei dipana con autentica partecipazione e profonda credibilità. Non ci sono baci, qualche stretta, eppure si percepisce sia una sensualità della giovane donna che la violenza subita dalla protagonista per l'asciuttezza dei dialoghi e le giuste sequenze di collocazione di quel costume sociale ipocrita e addirittura negazionista di diritti di parità sociale. Insomma questo è il nostro cinema che deve girare perché in esso c'è il nostro passato che comincia ad essere raccontato in quegli anni così crudo come è necessario che sia se vogliamo avvicinarci alla verità sociale e descriverne le sue contraddizioni con opere di emancipazione nella quale diamo un valore alla dignità della persona.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=jTHEPiqF4sI&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=4
Un esercizio di cinema riuscitissimo, gli attori tutti calati nello loro parte credibili come personaggi di una storia italiana fortemente di costume sociale e morale. Un soggetto che ci provoca rabbia e nostalgia. La prima per la violenza nei confronti delle donne e la seconda per un mondo che non può più esistere, in cui gli uomini vivevano nel paesaggio di una natura ciclica, anche se la sceneggiatura di questa parabola del "figlio prodigo" cristiana non ci nasconde la crisi proprio di quella comunità di valori dalle insidie di un nascente mondo urbano nel sottofondo del testo. Le inquadrature sono un saggio di cinema e spiccano; la prima, di apertura, sui primi piani delle donne al Bar della casa di appuntamenti, la scala della fuga dalla casa materna, l'attraversamento del ponte sulla bruma e il totale di Maria che si staglia contro il cielo in campagna presso i suoi salvatori. Tante le vicende e le sofferenza di una giovane, che abbandonata, diventa preda dei più vili ricattatori oltre che bersaglio della viltà maschile. I campi lunghi della campagna, i totali e i primi piani ben scelti nel ritmo della narrazione escono dal sentimentalismo e riescono quasi a conferire alla storia un possibile tono epico. Non rinunzia, il regista a una vene dialettica dell'autocritica sociale e di costume dando a Pietro, il giovane fidanzato, incontrato dopo la maternità e perdita del bambino, un momento di coscienza critica di domanda sulla dignità umana e di senso di colpa meritato quando insistente nel pregiudizio, ma soprattutto di corresponsabilità delle azioni umane intraprese da ciascun appartenente alla comunità, se vogliamo chiamarla tale. Il bianco e nero è morbido nella fotografia e ciononostante sottende in certi momenti una lezione espressionista, di luci reali, senza intensificazioni di scena. Si passano i diversi livelli di grigi per arrivare nello scorrere di una sequenza al nero totale dell'intera inquadratura e perciò lo schermo finestra della proiezione acquista un valore simbolico: il nero non del peccato ma della risposta sociale e umana al dramma di una giovane donna ingannata e umiliata. L'intero soggetto svolto con una sceneggiatura accurata eppure sobria risente di una necessità di uno sguardo letterario e forse in più punti anche di un ritmo letterario, ma tutto è molto naturale e spontaneo e seppure non ci sono rilevanti sorprese lungo la durata del film, o almeno non così imprevedibili dopo le premesse di apertura, alcuni passaggi temporali riescono a sviluppare la dinamica dialettica delle coscienze fino all'amore, prima di ogni coscienza, fatto di corpo, che dà vita e protegge altro corpo come quello della madre; è in questa esperienza della maternità vissuta data e ricevuta che Maria ritrova la forza di chiedere accoglienza, giudizio ma soprattutto amore, quell'amore che gli uomini hanno utilizzato per ingannarla, umiliarla, sfruttarla, violentarla. Nei movimenti di macchina, mimetici e solo in alcune scene accennati, sottolineano il punto di osservazione della storia come se leggessimo una lettera e questa voce è di Maria, la protagonista, i cui primi piani rendono pienamente la mimica dei sentimenti la variabilità delle situazioni. I dialoghi sono precisi e seguibili come la colonna sonora, seppure priva di motivi ricorrenti, di temi, come accade oggi, è ben amalgamata con lo sviluppo delle vicende, senza ridondanze o effettismi. Il cinema delle nostre origini matura la sua parabola in queste pellicole dignitosissime che sono state lavorate agli esordi del centro sperimentale per la cinematografia e così cresce l'insegnamento e la critica del linguaggio di un'arte che aveva pochi decenni di storia; è meritevole il coinvolgimento degli allievi con i maestri, Barbaro, Chiarini, Pasinetti come Palermi; essi sono quel fondamento che ha permesso il nostro cinema realista di dettare la nuova semplicità e soprattutto autenticità di narrare storie visive e sonore. Oggi dobbiamo prendere lezione da questi maestri. I nuovi canoni estetici saranno accennati dalla lezione del cinema italiano sia muto che sonoro, ricordiamo solo Assunta Spina, cult movie della cinematografia mondiale. Il feedback su cui è costruita la storia è molto spontaneo, pertinente ed efficacemente risolutivo in senso stilistico, conferisce a Paola Barbara la centralità della conduzione in soggettiva che lei dipana con autentica partecipazione e profonda credibilità. Non ci sono baci, qualche stretta, eppure si percepisce sia una sensualità della giovane donna che la violenza subita dalla protagonista per l'asciuttezza dei dialoghi e le giuste sequenze di collocazione di quel costume sociale ipocrita e addirittura negazionista di diritti di parità sociale. Insomma questo è il nostro cinema che deve girare perché in esso c'è il nostro passato che comincia ad essere raccontato in quegli anni così crudo come è necessario che sia se vogliamo avvicinarci alla verità sociale e descriverne le sue contraddizioni con opere di emancipazione nella quale diamo un valore alla dignità della persona.
La lupa 1953 di Alberto Lattuada
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=gVtRCXza_hM
Il soggetto è liberamente interpretato e come accade per molte altre storie il film che ne nasce è tutt’altra opera che quella letteraria. Lo scrittore verista colloca la vicenda in un provocatorio conflitto tra ipocrisia e libera sessualità comparativamente nella borghesia e tra il ceto popolare dei contadini, mentre il regista italiano trasforma la storia in una costruzione borghese allusiva alla tragedia che pur è nell’epilogo della narrazione, ma più violento e senza appello.
Da una novella di Verga, scrittore di talento del naturalismo italiano, Lattuada sa farne cinema.
Inquadrature essenziali, tempi di recitazione, ambientazione scelte, tutte riuscite e convincenti.
Lo spostamento nella contemporaneità della vicenda dal secolo precedente in cui l’aveva collocata l’autore siciliano è pertinente, perché il tema i moventi e le dinamiche sociali sono rimaste le stesse; questo è l’intuito profondo e onesto del regista che assieme a collaboratori di prestigio, Moravia, Perilli, sviluppa una sceneggiatura davvero coinvolgente, in cui i personaggi si stagliano con assoluta verità.
I protagonisti della vicenda consumeranno le loro miserie chi più chi meno con dignità. Anche “la lupa” artefice della sovversiva condotta, ai bordi dell’alienazione e della psicosi, caduta nella prostituzione, alla fine sceglie pe sé una morte dignitosa nelle fiamme, metaforiche dell’inferno. Il suo peccato è la sua bramosia, irrefrenabile all’istinto sessuale e seduttore. Le aperture di campo, i carrelli e i mezzi piani si articolano come sguardo del narratore portandoci dentro la vicenda immediatamente, senza preamboli. Domina la povertà dell’ambiente, del quotidiano e dei sentimenti, in un certo senso diretti, senza mezze misure, amore, innocenza, odio, vendetta, viltà. L’accompagnamento sonoro, anche se non proprio una colonna sonora è puntuale e sa cogliere le dinamiche drammaturgiche della storia. La fotografia così scarna in un bianco e nero esemplare ci racconta di un Italia impensabile oggi eppure c’è un senso profondo di comprensione, e, se non nostalgia, di empatia che ci lega ai personaggi, anche quelli più disgraziati come Pina e Maricchia, due facce della stessa medaglia, madre e figlia, antagoniste in un eros ridotto a miseria del quotidiano e sopravvivenza esistenziale.
E nei nodi dell’intreccio, piuttosto semplice come il diario di una vita senza particolari avventure, sappiamo cogliere quella carica di violenza che regna nelle vite della povera gente che non può sottrarsi dalla necessità di un ordine morale, pena la tragedia. Ecco il risvolto classico e antropologico che ci impegna a un giudizio non solo estetico ma morale. Si sente da parte del regista il desiderio di scavare nella psicologia del femminile per tirarne fuori delle verità e non le sue idee precostituite, riuscendo a dare volto negli sguardi di primo piano alle due protagoniste principalmente ma anche al personaggio maschile, il militare, benché la psicologia maschile è risolta con una più superficiale pennellata. L’ostilità della popolazione nel paese cresce lentamente con commenti che esprimono la coscienza critica e morale e lievita fino ad assumere una coralità da teatro greco. E quel nero degli abiti miseri di tutti i giorni diventa il nero della morte. “Cornute” griderà alla massa di donne che vogliono assalirle, una strana definizione che di solito è rivolta al maschile, ma qui, è giusto il termine, vista la forza di svelamento che deve ottenere, e cioè che i mariti di tutte o quasi vanno da lei per soddisfare la vita sessuale. Allora ecco l’ipocrisia che regna nascosta in un piccolo gruppo di una comunità seppure sospesa alle occasioni della sopravvivenza, il lavoro al tabacchificio per le donne, stagionale e sotto-sfruttato. Sarà in uno degli episodi di riapertura autunnale che si concentrerà lo scontro tra le protagoniste e il loro coro-di-lavoratrici-compaesane, messe in antagonismo non solo sessuale ma anche esistenziale; guadagnarsi un pezzo di pane.
L’irruenza volta solo all’istinto non la salverà neanche quando sarà al comando della fabbrica, avendo ceduto all’invito del “padrone” di accompagnarsi a lui non riuscirà a mediare il nuovo ruolo di donna del principale e perciò superiore alle lavoratrici. Anzi sceglierà la superbia e in un certo senso l’infierire, la vendetta come predestinazione alla quale non si può sottrarre in quanto percorso di forze non solo individuali ma collettive e sociali. Un messaggio duro ma realistico dell’autore che non sdolcina il film non lo edulcora in nessun modo per un pubblico consenziente.
Il carrello iniziale che apre sulla protagonista ci introduce non solo all’ambientazione ma al momento corale e festivo che il Paese sta organizzando in devozione di S. Agata la Patrona degli abitanti siciliani, catanesi, nella storia di Verga. La Processione dei fedeli che precede il concorso popolare è un nodo di tanta cinematografia italiana, terra ricca di riti e di manifestazioni popolari di culto cristiano. Anche qui, Lattuada, sa sapientemente descrivere con mescolanze di campi i preparativi delle giovani vergine che aspirano a interpretare la santa, spesso per espresso desiderio delle madri.
Quella stessa folla di madri che passerà dalla devozione al linciaggio scorrendo il tempo della vicenda nella miseria della popolazione chiusa tra le ombre del bianco nero ben riuscito di un tono e tavolozza neorealista, anche se un po’ tarda, comunque testimone della storia sociale ed economica del nostro Paese.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=gVtRCXza_hM
Il soggetto è liberamente interpretato e come accade per molte altre storie il film che ne nasce è tutt’altra opera che quella letteraria. Lo scrittore verista colloca la vicenda in un provocatorio conflitto tra ipocrisia e libera sessualità comparativamente nella borghesia e tra il ceto popolare dei contadini, mentre il regista italiano trasforma la storia in una costruzione borghese allusiva alla tragedia che pur è nell’epilogo della narrazione, ma più violento e senza appello.
Da una novella di Verga, scrittore di talento del naturalismo italiano, Lattuada sa farne cinema.
Inquadrature essenziali, tempi di recitazione, ambientazione scelte, tutte riuscite e convincenti.
Lo spostamento nella contemporaneità della vicenda dal secolo precedente in cui l’aveva collocata l’autore siciliano è pertinente, perché il tema i moventi e le dinamiche sociali sono rimaste le stesse; questo è l’intuito profondo e onesto del regista che assieme a collaboratori di prestigio, Moravia, Perilli, sviluppa una sceneggiatura davvero coinvolgente, in cui i personaggi si stagliano con assoluta verità.
I protagonisti della vicenda consumeranno le loro miserie chi più chi meno con dignità. Anche “la lupa” artefice della sovversiva condotta, ai bordi dell’alienazione e della psicosi, caduta nella prostituzione, alla fine sceglie pe sé una morte dignitosa nelle fiamme, metaforiche dell’inferno. Il suo peccato è la sua bramosia, irrefrenabile all’istinto sessuale e seduttore. Le aperture di campo, i carrelli e i mezzi piani si articolano come sguardo del narratore portandoci dentro la vicenda immediatamente, senza preamboli. Domina la povertà dell’ambiente, del quotidiano e dei sentimenti, in un certo senso diretti, senza mezze misure, amore, innocenza, odio, vendetta, viltà. L’accompagnamento sonoro, anche se non proprio una colonna sonora è puntuale e sa cogliere le dinamiche drammaturgiche della storia. La fotografia così scarna in un bianco e nero esemplare ci racconta di un Italia impensabile oggi eppure c’è un senso profondo di comprensione, e, se non nostalgia, di empatia che ci lega ai personaggi, anche quelli più disgraziati come Pina e Maricchia, due facce della stessa medaglia, madre e figlia, antagoniste in un eros ridotto a miseria del quotidiano e sopravvivenza esistenziale.
E nei nodi dell’intreccio, piuttosto semplice come il diario di una vita senza particolari avventure, sappiamo cogliere quella carica di violenza che regna nelle vite della povera gente che non può sottrarsi dalla necessità di un ordine morale, pena la tragedia. Ecco il risvolto classico e antropologico che ci impegna a un giudizio non solo estetico ma morale. Si sente da parte del regista il desiderio di scavare nella psicologia del femminile per tirarne fuori delle verità e non le sue idee precostituite, riuscendo a dare volto negli sguardi di primo piano alle due protagoniste principalmente ma anche al personaggio maschile, il militare, benché la psicologia maschile è risolta con una più superficiale pennellata. L’ostilità della popolazione nel paese cresce lentamente con commenti che esprimono la coscienza critica e morale e lievita fino ad assumere una coralità da teatro greco. E quel nero degli abiti miseri di tutti i giorni diventa il nero della morte. “Cornute” griderà alla massa di donne che vogliono assalirle, una strana definizione che di solito è rivolta al maschile, ma qui, è giusto il termine, vista la forza di svelamento che deve ottenere, e cioè che i mariti di tutte o quasi vanno da lei per soddisfare la vita sessuale. Allora ecco l’ipocrisia che regna nascosta in un piccolo gruppo di una comunità seppure sospesa alle occasioni della sopravvivenza, il lavoro al tabacchificio per le donne, stagionale e sotto-sfruttato. Sarà in uno degli episodi di riapertura autunnale che si concentrerà lo scontro tra le protagoniste e il loro coro-di-lavoratrici-compaesane, messe in antagonismo non solo sessuale ma anche esistenziale; guadagnarsi un pezzo di pane.
L’irruenza volta solo all’istinto non la salverà neanche quando sarà al comando della fabbrica, avendo ceduto all’invito del “padrone” di accompagnarsi a lui non riuscirà a mediare il nuovo ruolo di donna del principale e perciò superiore alle lavoratrici. Anzi sceglierà la superbia e in un certo senso l’infierire, la vendetta come predestinazione alla quale non si può sottrarre in quanto percorso di forze non solo individuali ma collettive e sociali. Un messaggio duro ma realistico dell’autore che non sdolcina il film non lo edulcora in nessun modo per un pubblico consenziente.
Il carrello iniziale che apre sulla protagonista ci introduce non solo all’ambientazione ma al momento corale e festivo che il Paese sta organizzando in devozione di S. Agata la Patrona degli abitanti siciliani, catanesi, nella storia di Verga. La Processione dei fedeli che precede il concorso popolare è un nodo di tanta cinematografia italiana, terra ricca di riti e di manifestazioni popolari di culto cristiano. Anche qui, Lattuada, sa sapientemente descrivere con mescolanze di campi i preparativi delle giovani vergine che aspirano a interpretare la santa, spesso per espresso desiderio delle madri.
Quella stessa folla di madri che passerà dalla devozione al linciaggio scorrendo il tempo della vicenda nella miseria della popolazione chiusa tra le ombre del bianco nero ben riuscito di un tono e tavolozza neorealista, anche se un po’ tarda, comunque testimone della storia sociale ed economica del nostro Paese.
Paolo e Francesca 1949 di Raffaello Matarazzo
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=1aiqd4oSSBI&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=5
Un dignitoso omaggio a Dante e alle origini del nostro narrarci di costumi e passioni. Intenso il movimento di camere in una sceneggiatura sobria e puntuale delle ipotesi della vicenda tragica. Matarazzo mostra una mano di conduzione ferma e sicura, Ne descrive i caratteri con poche azioni in un b/n fotografico che ci convince nonostante siamo negli anni '50 del cinema italiano. La tensione dell'innamoramento che nella sceneggiatura non ha nulla di peccaminoso è ben tenuta e credibile. L'escamotage dell'incontro di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, nel convento trasformato in ospedale per l'assedio di Gianciotto, fratello di Paolo, non disturba l'incertezza filologica di come siano andati veramente i fatti. Certo è che l'adulterio nello svolgimento storico fu più colpevole se così si può dire, perché Paolo Malatesta aveva moglie. Il sonoro (del maestro Cicognini con le bellissime canzoni cantate da Roberto Murolo) di grande accompagnamento riesce a descriverne i moti dei personaggi implicati nella vicenda e allo stesso tempo riesce a colorire anche quelle sequenze di esterni che muovono la storia da un piano psicologico alla concretezza di Casati, famiglie e popolo contadino a queste legate indissolubilmente. Il destino li ha beffati, questi due giovani, attirandoli in un vortice di sensi a cui non si sono e non hanno voluto sottrarsi, consapevoli del rischio di finire in un legame tragico. L'unico appunto, che per altro è comune alla condotta di tanto cinema adattato da storie vere e di costume, o grandi classici, è quello di non rispettare la verosimiglianza di giovani ancora quasi adolescenti, centrali protagonisti di queste leggendarie vicende. Uno sforzo che oggi richiede più impegno di quando i film avevano i loro battesimi di sala e di pubblico. Questi adulti che recitano a giovani, oggi, ci disorientano un poco, perchè chiediamo più verità d'azione e di contesto. Motivo che spinse il nostro cinema al set autentico della strada e dei suoi occasionali avventori. M. è un regista e intellettuale che dovremmo prendere ad esempio per essersi battuto a fondare i luoghi di apprendimento della nostra lingua cinematografica e narrare il Paese, impegno altrettanto urgente dei nostri tempi, morale e artistico.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=1aiqd4oSSBI&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=5
Un dignitoso omaggio a Dante e alle origini del nostro narrarci di costumi e passioni. Intenso il movimento di camere in una sceneggiatura sobria e puntuale delle ipotesi della vicenda tragica. Matarazzo mostra una mano di conduzione ferma e sicura, Ne descrive i caratteri con poche azioni in un b/n fotografico che ci convince nonostante siamo negli anni '50 del cinema italiano. La tensione dell'innamoramento che nella sceneggiatura non ha nulla di peccaminoso è ben tenuta e credibile. L'escamotage dell'incontro di Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, nel convento trasformato in ospedale per l'assedio di Gianciotto, fratello di Paolo, non disturba l'incertezza filologica di come siano andati veramente i fatti. Certo è che l'adulterio nello svolgimento storico fu più colpevole se così si può dire, perché Paolo Malatesta aveva moglie. Il sonoro (del maestro Cicognini con le bellissime canzoni cantate da Roberto Murolo) di grande accompagnamento riesce a descriverne i moti dei personaggi implicati nella vicenda e allo stesso tempo riesce a colorire anche quelle sequenze di esterni che muovono la storia da un piano psicologico alla concretezza di Casati, famiglie e popolo contadino a queste legate indissolubilmente. Il destino li ha beffati, questi due giovani, attirandoli in un vortice di sensi a cui non si sono e non hanno voluto sottrarsi, consapevoli del rischio di finire in un legame tragico. L'unico appunto, che per altro è comune alla condotta di tanto cinema adattato da storie vere e di costume, o grandi classici, è quello di non rispettare la verosimiglianza di giovani ancora quasi adolescenti, centrali protagonisti di queste leggendarie vicende. Uno sforzo che oggi richiede più impegno di quando i film avevano i loro battesimi di sala e di pubblico. Questi adulti che recitano a giovani, oggi, ci disorientano un poco, perchè chiediamo più verità d'azione e di contesto. Motivo che spinse il nostro cinema al set autentico della strada e dei suoi occasionali avventori. M. è un regista e intellettuale che dovremmo prendere ad esempio per essersi battuto a fondare i luoghi di apprendimento della nostra lingua cinematografica e narrare il Paese, impegno altrettanto urgente dei nostri tempi, morale e artistico.
La donna che venne dal mare 1956 di Francesco de Robertis
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=hnN9hMjqGTU&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=6
Film perfetto nella conduzione e interpretazione con un commento musicale sempre pertinente. La protagonista, Sandra Milo, accanto a Vittorio De Sica, è magistrale in una recitazione sempre sul filo della suspence. La sceneggiatura d'azione di scarno sentimentalismo riesce pienamente a costruire quell'atmosfera di guerra e di spionaggio senza esagerare né cadere nel bozzettismo militare. Le inquadrature tutte sapientemente intrecciate danno all'insieme un ritmo sospeso e fortemente evocativo. Gli esterni e gli interni ben articolati nelle azioni conferiscono un certo movimento di temporalità spaziale alla narrazione e ne illustrano un molto verosimile ambiente reale con una fotografia naturalistica ma non priva di una spessore stilistico, un morbido b/n. Lo sviluppo psicologico della protagonista è ben calibrato e pertinentemente narrato con pochi ma significativi tratti sensibili come l'inquadratura di Danae in uno splendido dolcevita bianco che si rivolge a Dario facendo una mezza torsione sulla sedia e mostrando sensualmente l'intimità dei seni generosi. I baci, si, i due baci in finale prima della disgrazia in cui Dario perderà la vita nella missione militare sono una vera e propria concentrazione della storia che ci svelano una mutazione profonda in entrambi i personaggi oramai innamorati nonostante i pericoli. Lei che esordisce come un'avventuriera che fa il prezzo per ogni missione viene colta dalla rimozione della sua natura di donna che è l'amore; sarà la battuta finale al congedo con il comandante. Nessun isterico pianto scenico eppure quel dolore lo percepiamo ed è nella mimica della Milo nella sua gesticolazione, in quella capacità di essere in scena senza riserve, con tutta se stessa. In questo film è bellissima nel suo più naturale aspetto molto adatta la personaggio della storia e capace di recitare con una misura che ci seduce con gran fascino. Geniale e da manuale tanto l'apertura sul peschereccio dell'inquadratura in cabina puntata sulle gambe della protagonista mentre s'infila le calze quanto nella scena finale che prende il mare con la barca in una vistosa giornata di cattivo tempo. Sapiente la chiusura. La donna che venne dal mare ritornò al mare.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=hnN9hMjqGTU&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=6
Film perfetto nella conduzione e interpretazione con un commento musicale sempre pertinente. La protagonista, Sandra Milo, accanto a Vittorio De Sica, è magistrale in una recitazione sempre sul filo della suspence. La sceneggiatura d'azione di scarno sentimentalismo riesce pienamente a costruire quell'atmosfera di guerra e di spionaggio senza esagerare né cadere nel bozzettismo militare. Le inquadrature tutte sapientemente intrecciate danno all'insieme un ritmo sospeso e fortemente evocativo. Gli esterni e gli interni ben articolati nelle azioni conferiscono un certo movimento di temporalità spaziale alla narrazione e ne illustrano un molto verosimile ambiente reale con una fotografia naturalistica ma non priva di una spessore stilistico, un morbido b/n. Lo sviluppo psicologico della protagonista è ben calibrato e pertinentemente narrato con pochi ma significativi tratti sensibili come l'inquadratura di Danae in uno splendido dolcevita bianco che si rivolge a Dario facendo una mezza torsione sulla sedia e mostrando sensualmente l'intimità dei seni generosi. I baci, si, i due baci in finale prima della disgrazia in cui Dario perderà la vita nella missione militare sono una vera e propria concentrazione della storia che ci svelano una mutazione profonda in entrambi i personaggi oramai innamorati nonostante i pericoli. Lei che esordisce come un'avventuriera che fa il prezzo per ogni missione viene colta dalla rimozione della sua natura di donna che è l'amore; sarà la battuta finale al congedo con il comandante. Nessun isterico pianto scenico eppure quel dolore lo percepiamo ed è nella mimica della Milo nella sua gesticolazione, in quella capacità di essere in scena senza riserve, con tutta se stessa. In questo film è bellissima nel suo più naturale aspetto molto adatta la personaggio della storia e capace di recitare con una misura che ci seduce con gran fascino. Geniale e da manuale tanto l'apertura sul peschereccio dell'inquadratura in cabina puntata sulle gambe della protagonista mentre s'infila le calze quanto nella scena finale che prende il mare con la barca in una vistosa giornata di cattivo tempo. Sapiente la chiusura. La donna che venne dal mare ritornò al mare.
Maruzzella 1956 di Luigi Capuano
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=Ahd6tvRqeMY&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=2
Film ridotto a quadri di scena con una trama esile e una sceneggiatura fragile che però viene sorretta e più spesso sostituita dalla procace presenza di Marisa Allasio che domina la scena totale in ogni momento della storia. L'altra parte dell'equilibrio è nelle canzoni di Carosone che veste il profilo di un personaggio romantico e piuttosto antitetico al suo reale carattere. Il dramma che la storia vorrebbe esprimere non è stato costruito con progressione e il regista si è fatto distrarre dal paesaggio o dalla protagonista che per quei tempi avrà suscitato intensi desideri sessuali; esemplari piani americani in spiaggia, l'attillato costume prima bikini poi il rosso porpora modellano le forme più intime. Forse in questi tagli d'inquadrature e un poco nella variazione del ritmo si sarebbe potuto trovare la chiave per una maggiore suspense e coinvolgimento emotivo. Il linguaggio del cinema ne esce un poco affaticato, Il personaggio maschile Salvatore in quel ruolo è veramente debole inesistente direi. Se non voleva avere gli occhi per il paesaggio e le orecchie per le magnifiche canzoni poteva averli almeno per la solarità di Marisa, unico neo di credibilità l'età troppo avanzata per sembrare una minorenne. Lo sviluppo della storia risulta condotta in un modo un poco esangue e lo pensiamo un involontario torto alla Napoli che canta il suo amore per Maruzzella con una sovranità assoluta su tutto il film.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=Ahd6tvRqeMY&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=2
Film ridotto a quadri di scena con una trama esile e una sceneggiatura fragile che però viene sorretta e più spesso sostituita dalla procace presenza di Marisa Allasio che domina la scena totale in ogni momento della storia. L'altra parte dell'equilibrio è nelle canzoni di Carosone che veste il profilo di un personaggio romantico e piuttosto antitetico al suo reale carattere. Il dramma che la storia vorrebbe esprimere non è stato costruito con progressione e il regista si è fatto distrarre dal paesaggio o dalla protagonista che per quei tempi avrà suscitato intensi desideri sessuali; esemplari piani americani in spiaggia, l'attillato costume prima bikini poi il rosso porpora modellano le forme più intime. Forse in questi tagli d'inquadrature e un poco nella variazione del ritmo si sarebbe potuto trovare la chiave per una maggiore suspense e coinvolgimento emotivo. Il linguaggio del cinema ne esce un poco affaticato, Il personaggio maschile Salvatore in quel ruolo è veramente debole inesistente direi. Se non voleva avere gli occhi per il paesaggio e le orecchie per le magnifiche canzoni poteva averli almeno per la solarità di Marisa, unico neo di credibilità l'età troppo avanzata per sembrare una minorenne. Lo sviluppo della storia risulta condotta in un modo un poco esangue e lo pensiamo un involontario torto alla Napoli che canta il suo amore per Maruzzella con una sovranità assoluta su tutto il film.
Il tetto 1956 Vittorio de Sica
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=9XaV3hOYunI&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=7
La grande lezione del cinema di Chaplin si respira in questa sceneggiatura di Zavattini-De Sica. La conduzione e il ritmo della narrazione ha quel sapore di vero che il maestro del neorealismo sapeva infondere ai suoi attori, professionisti o dalla strada, che non recitano ma vivono. Nessuno guarda questo film come un film, ma come un documento di vita. I volti della protagonista della sua amica a servizio del cognato dei vecchi degli amici manovali e muratori sono un affresco di costume e di verità. La progressione della storia riesce a sostenere un coinvolgimento emotivo e a farci sentire partecipi ora del punto di vista dell'uno ora quello dell'altro personaggio: L'empatia per i due giovani, Natale emigrato dal veneto con la sua famiglia, e Luisa, figlia di pescatore, (Giorgio Listuzzi; Gabriella Pallotta) nasce sin dalle prime immagini e si mescola più volte a una giusta rabbia e direi lotta, amarezza per una sorte che riteniamo umilii la persona, la sua dignità. Una gioventù certo molto diversa da quella di oggi, a tratti disperata ma incolpevole della sua miseria. Ne percepiamo il coraggio, la resistenza che chiude in positivo, in ottimismo la vicenda della costruzione della casa; il tetto sotto il cielo; quanti rimandi al Monello e alle innumerevoli speranza del nostro Charlot. Tutto comincia con la speranza fin dalle scene del matrimonio, delle foto ricordo, dell'amica che prenderà il suo posto a servizio, in una gestualità che non è filmica ma quotidiana sottolineata da battute in un copione più volte dialettale, con sapienza esaltato da commenti musicali fortemente espressivi e riuscitissimi.( Maestro Cicognini ). La camera scompare nelle sequenze lente e nei primi piani, discreti, mai fotografici, scelti a costruire la situazione emotiva drammatica. Non c'è esagerazione neanche nel litigio con il cognato; qui riesce ad essere misurato e lasciare che il dramma segua quasi una sua pagina epica facendosi simbolo di una generazione e di una classe sociale che cerca in tutti i modi di sopravvivere, di farsi largo dalla miseria, da una ingiusta ripartizione delle risorse. I grandi edifici che fanno da scenografia e fondale a questi luoghi tra il selvaggio e l'esclusione dei nuovi quartieri, sottolineano l'emarginazione in cui si lotta per non soccombere; è un manifesto visivo che ben conosciamo, iconico che non ha bisogno di parole né commenti. La solidarietà dei compagni di cantiere che si affrettano in una notte a tirare su le mura di una casa abusiva in una borgata sulle sponde dell'Aniene, grande quanto uno ripostiglio meno di 10 metri quadri, costituisce il tema etico della storia in cui non possiamo dimenticare quello che siamo stati: un Paese vinto dalla guerra, lasciato in miseria. Il colpo magistrale della solidarietà è alla fine quando Cesare corre a dargli una mano dimenticando i rancori e le donne che danno i consigli su come ricevere i carabinieri mentre una di questa darà in braccio a Luisa il proprio figlio per simulare la famiglia con prole d'infanzia; stretta nel fiato tra quelle quattro mura, e solo mezzo tetto per cielo; è proprio il caso di dirlo, affidati solo alla provvidenza. Le trovate, sia del ragazzino che della finta lotta tra alcuni compagni, sono di nuovo le gag del muto; qui muto è il dolore da portarsi dentro e convivere nella lotta e nella speranza, come la intransigenza del padre di Luisa, pescatore che non abbraccerà né perdonerà la propria figlia quando questa farà visita con il giovane sposo alla loro casa modesta sul litorale. Quali umiliazioni una giovane e un giovane devono portarsi dentro per vivere con dignità, ecco il massaggio di De Sica, senza sentimentalismi ma con la giusta crudezza per ammonirci, oggi, di non dimenticare chi ha costruito questa Italia.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=9XaV3hOYunI&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=7
La grande lezione del cinema di Chaplin si respira in questa sceneggiatura di Zavattini-De Sica. La conduzione e il ritmo della narrazione ha quel sapore di vero che il maestro del neorealismo sapeva infondere ai suoi attori, professionisti o dalla strada, che non recitano ma vivono. Nessuno guarda questo film come un film, ma come un documento di vita. I volti della protagonista della sua amica a servizio del cognato dei vecchi degli amici manovali e muratori sono un affresco di costume e di verità. La progressione della storia riesce a sostenere un coinvolgimento emotivo e a farci sentire partecipi ora del punto di vista dell'uno ora quello dell'altro personaggio: L'empatia per i due giovani, Natale emigrato dal veneto con la sua famiglia, e Luisa, figlia di pescatore, (Giorgio Listuzzi; Gabriella Pallotta) nasce sin dalle prime immagini e si mescola più volte a una giusta rabbia e direi lotta, amarezza per una sorte che riteniamo umilii la persona, la sua dignità. Una gioventù certo molto diversa da quella di oggi, a tratti disperata ma incolpevole della sua miseria. Ne percepiamo il coraggio, la resistenza che chiude in positivo, in ottimismo la vicenda della costruzione della casa; il tetto sotto il cielo; quanti rimandi al Monello e alle innumerevoli speranza del nostro Charlot. Tutto comincia con la speranza fin dalle scene del matrimonio, delle foto ricordo, dell'amica che prenderà il suo posto a servizio, in una gestualità che non è filmica ma quotidiana sottolineata da battute in un copione più volte dialettale, con sapienza esaltato da commenti musicali fortemente espressivi e riuscitissimi.( Maestro Cicognini ). La camera scompare nelle sequenze lente e nei primi piani, discreti, mai fotografici, scelti a costruire la situazione emotiva drammatica. Non c'è esagerazione neanche nel litigio con il cognato; qui riesce ad essere misurato e lasciare che il dramma segua quasi una sua pagina epica facendosi simbolo di una generazione e di una classe sociale che cerca in tutti i modi di sopravvivere, di farsi largo dalla miseria, da una ingiusta ripartizione delle risorse. I grandi edifici che fanno da scenografia e fondale a questi luoghi tra il selvaggio e l'esclusione dei nuovi quartieri, sottolineano l'emarginazione in cui si lotta per non soccombere; è un manifesto visivo che ben conosciamo, iconico che non ha bisogno di parole né commenti. La solidarietà dei compagni di cantiere che si affrettano in una notte a tirare su le mura di una casa abusiva in una borgata sulle sponde dell'Aniene, grande quanto uno ripostiglio meno di 10 metri quadri, costituisce il tema etico della storia in cui non possiamo dimenticare quello che siamo stati: un Paese vinto dalla guerra, lasciato in miseria. Il colpo magistrale della solidarietà è alla fine quando Cesare corre a dargli una mano dimenticando i rancori e le donne che danno i consigli su come ricevere i carabinieri mentre una di questa darà in braccio a Luisa il proprio figlio per simulare la famiglia con prole d'infanzia; stretta nel fiato tra quelle quattro mura, e solo mezzo tetto per cielo; è proprio il caso di dirlo, affidati solo alla provvidenza. Le trovate, sia del ragazzino che della finta lotta tra alcuni compagni, sono di nuovo le gag del muto; qui muto è il dolore da portarsi dentro e convivere nella lotta e nella speranza, come la intransigenza del padre di Luisa, pescatore che non abbraccerà né perdonerà la propria figlia quando questa farà visita con il giovane sposo alla loro casa modesta sul litorale. Quali umiliazioni una giovane e un giovane devono portarsi dentro per vivere con dignità, ecco il massaggio di De Sica, senza sentimentalismi ma con la giusta crudezza per ammonirci, oggi, di non dimenticare chi ha costruito questa Italia.
Miracolo a Piedigrotta: il voto 1950 di M. Bonnard
per guardare il film:
https://www.youtube.com/watch?v=iqyDMTxOJJ0&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=8
Si mescolano i miei ricordi dell'infanzia in questa Piedigrotta così corale, struggente, vera. Bonnard riesce a tenere in una sola inquadratura tutto il film; è una inquadratura del linguaggio del cinema: un campo medio che stringe su un primo piano e viceversa, e una inquadratura dell'anima. E ce n'è tanta in questa storia. Superstizione e passione, tradimento e generosità, tutti ingredienti di cuore che esaltano comunque l'umano nella sua più fragile quotidianità. Un giovane pescatore stringe una relazione con la moglie di un suo amico partito in navigazione verso l'oriente, e per questo sgarro viene accusato di malaugurio del mare dai suoi compagni; lo stesso, per uscire dal conflitto di colpa che lo fa soffrire, stringe un voto con la Madonna: salvare una donna dalla prostituzione, Cristina (detta la Capuana), che finirà per amare. Un soggetto e una sceneggiatura nell'impronta romanzata di Salvatore Di Giacomo, così naturale che non sembra neanche un film, piuttosto la narrazione di una cronaca napoletana, credibilissima. I gesti, gli accenti, il tono e le battute sono senza sforzi come presi dal vivo con un lento procedere della canzone che da fiorita rosa di maggio si fa poco alla volta appassionata e poi malinconica per finire struggente nella turbolenza della festa animata dal contrasto tra chi si diverte senza pensieri, lasciandosi andare a un momento di fuga ma anche di riposo dalla vita quotidiana, e chi nella propria coscienza sta scontando un voto in un conflitto, Vito e Cristina che li porta a una trasformazione dell'esistenza, al miracolo dell'amore. Si, perché nella solarità della città di Napoli c'è in contrappunto l'ombra: la miseria, la fatica e anche il peccato, la malasorte, la condanna sociale. In queste due forme diverse di amore, quello di Carmela che è una donna sposata, il cui marito, marinaio, è partito imbarcato per la Cina e quello di Cristina che ingannata e tradita dagli uomini si era rassegnata ad una vita infelice e umiliata. Le donne, si, sono le protagoniste principali del film. Vito è il maschile anche un poco capriccioso e infantile che cerca una sua morale per uscire dai sensi di colpa dei paradigmi sociali. La salvezza sta in quella bambola presa al mercato: " - comme e' bellella- tene l'uocchie celeste- si... comme o' mare" nella battuta che sta per l'innocente da salvare. E la macchina da presa che indugia sui primi piani incorniciando profondi ritratti riesce a dare spessore anche a quei volti, non in finzione da rotocalco hollywoodiano, bensì di testimonianza emotiva in una ritrattistica da scena senza belletti. La fotografia è delicata sicura e tocca il cuore, non ci sono neri espressionistici ma ci restituisce la luce realistica e il temperamento emotivo delle situazioni. Geniale l'intesa della colonna sonora curata dal fratello del regista Giulio, con i classici della canzone napoletana cantati da un Murolo camuffato da mendicante con la chitarra; ed anche questa soluzione ci conferma del buon gusto della regia e soprattutto del desiderio di comporre in una sola idea l'aria di cartolina della città in un b/n assolutamente luminoso e accorato ma non didascalico né affettato. Rimpiangiamo quel calore e forse anche quella ingenuità espressa da un mondo così diverso dalla nostro società contemporanea alienata negli affetti, e soprattutto sulla strada di una commozione e umanità diminuita. Finanche quell'indigenza e la modestia di vite che sbarcano il lunario ci sembrano, anzi, sono migliori delle nostre meno corrotte nelle radici. Con possibilità di salvezza se il coraggio svolge la sua parte come avviene per il "voto" dato dal marinaio. Una buona azione, nata per catartizzare il senso di colpa di un'avventura amorosa non approvata dalla condotta del conformismo sociale, che si radica nel cuore con un sentimento autentico dei due giovani protagonisti condotti a chiudere la scena alla maniera di Chaplin, e del suo ottimismo per la vita, perché quando ci sembra senza scampo il nostro destino, una nuova strada è sempre possibile.
per guardare il film:
https://www.youtube.com/watch?v=iqyDMTxOJJ0&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=8
Si mescolano i miei ricordi dell'infanzia in questa Piedigrotta così corale, struggente, vera. Bonnard riesce a tenere in una sola inquadratura tutto il film; è una inquadratura del linguaggio del cinema: un campo medio che stringe su un primo piano e viceversa, e una inquadratura dell'anima. E ce n'è tanta in questa storia. Superstizione e passione, tradimento e generosità, tutti ingredienti di cuore che esaltano comunque l'umano nella sua più fragile quotidianità. Un giovane pescatore stringe una relazione con la moglie di un suo amico partito in navigazione verso l'oriente, e per questo sgarro viene accusato di malaugurio del mare dai suoi compagni; lo stesso, per uscire dal conflitto di colpa che lo fa soffrire, stringe un voto con la Madonna: salvare una donna dalla prostituzione, Cristina (detta la Capuana), che finirà per amare. Un soggetto e una sceneggiatura nell'impronta romanzata di Salvatore Di Giacomo, così naturale che non sembra neanche un film, piuttosto la narrazione di una cronaca napoletana, credibilissima. I gesti, gli accenti, il tono e le battute sono senza sforzi come presi dal vivo con un lento procedere della canzone che da fiorita rosa di maggio si fa poco alla volta appassionata e poi malinconica per finire struggente nella turbolenza della festa animata dal contrasto tra chi si diverte senza pensieri, lasciandosi andare a un momento di fuga ma anche di riposo dalla vita quotidiana, e chi nella propria coscienza sta scontando un voto in un conflitto, Vito e Cristina che li porta a una trasformazione dell'esistenza, al miracolo dell'amore. Si, perché nella solarità della città di Napoli c'è in contrappunto l'ombra: la miseria, la fatica e anche il peccato, la malasorte, la condanna sociale. In queste due forme diverse di amore, quello di Carmela che è una donna sposata, il cui marito, marinaio, è partito imbarcato per la Cina e quello di Cristina che ingannata e tradita dagli uomini si era rassegnata ad una vita infelice e umiliata. Le donne, si, sono le protagoniste principali del film. Vito è il maschile anche un poco capriccioso e infantile che cerca una sua morale per uscire dai sensi di colpa dei paradigmi sociali. La salvezza sta in quella bambola presa al mercato: " - comme e' bellella- tene l'uocchie celeste- si... comme o' mare" nella battuta che sta per l'innocente da salvare. E la macchina da presa che indugia sui primi piani incorniciando profondi ritratti riesce a dare spessore anche a quei volti, non in finzione da rotocalco hollywoodiano, bensì di testimonianza emotiva in una ritrattistica da scena senza belletti. La fotografia è delicata sicura e tocca il cuore, non ci sono neri espressionistici ma ci restituisce la luce realistica e il temperamento emotivo delle situazioni. Geniale l'intesa della colonna sonora curata dal fratello del regista Giulio, con i classici della canzone napoletana cantati da un Murolo camuffato da mendicante con la chitarra; ed anche questa soluzione ci conferma del buon gusto della regia e soprattutto del desiderio di comporre in una sola idea l'aria di cartolina della città in un b/n assolutamente luminoso e accorato ma non didascalico né affettato. Rimpiangiamo quel calore e forse anche quella ingenuità espressa da un mondo così diverso dalla nostro società contemporanea alienata negli affetti, e soprattutto sulla strada di una commozione e umanità diminuita. Finanche quell'indigenza e la modestia di vite che sbarcano il lunario ci sembrano, anzi, sono migliori delle nostre meno corrotte nelle radici. Con possibilità di salvezza se il coraggio svolge la sua parte come avviene per il "voto" dato dal marinaio. Una buona azione, nata per catartizzare il senso di colpa di un'avventura amorosa non approvata dalla condotta del conformismo sociale, che si radica nel cuore con un sentimento autentico dei due giovani protagonisti condotti a chiudere la scena alla maniera di Chaplin, e del suo ottimismo per la vita, perché quando ci sembra senza scampo il nostro destino, una nuova strada è sempre possibile.
Il Sole sorge ancora 1946 di Aldo Vergano
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=XSV2nQZo35k&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=10
La guerra è sempre spietata; si vuole uccidere e si uccide, che sia un uomo con altri costumi, credo, lingua e cultura e finanche il proprio fratello. Ne abbiamo viste. Dopo i Romani, per non andare più indietro, i longobardi, i celti, i barbari, se preferite in una sola parola, gli ottomani, e ancora i franchi, gli spagnoli, i germanici, in seguito gli austroungarici e così via; e oggi è finita davvero? Non vi sembra? Il film: una narrazione ben riuscita tra il documentario e l'azione. Buona la mescolanza del racconto tra le sequenze di approfondimento psicologico dei personaggi con i piani ravvicinati, i primissimi piani e le scene di movimento e d'azione con i diversi punti di vista della ripresa. Quell'impronta di neorealismo che sarebbe impensabile oggi; i contadini erano veri con le loro facce segnate dalla fatica e dalla miseria, più che bozzetti, veri e propri ritratti da Goya o da Velasquez. Un'Italia che non esiste più, e ce ne dovremmo dolere, se non per la miseria, che pure è sempre dietro la porta, per la fierezza che si avverte come un contagio attivo di speranza verso il bene comune. La produzione e la sceneggiatura hanno raccolto con coraggio la dolorosa opportunità delle location veritiere dei bombardamenti e della distruzione appena passata. Il ritmo del racconto non ha cadute e i personaggi sono tutti credibili nelle loro azioni. Gli attori comunicano una buona dose di verità interiore e non cadono nella finzione scenica. Il b/n assume un valore non solo estetico ma quasi simbolico della crudezza di un dolore che ci portiamo dietro di tempi bui, in cui, ciononostante la violenza, nasce l'amore e anche la generosità; per fortuna qualcuno sempre lo testimonia a chi viene dopo. Ed io sono venuto dopo. Grazie!
Un ettaro di cielo 1958 di Aglauco Casadio
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=dCqVt6diYtA&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=9
La lezione di Chaplin è straordinariamente assimilata e tradotta in un soggetto tutto italiano e di originale impatto visivo. La sceneggiatura riesce a modellare i caratteri dei personaggi così bene che gli stessi ci appaiono vicini, confidenziali; ne condividiamo l'umanità anche se non ci riconosciamo nelle ingenuità, ma questa potrebbe essere la cosa che più ci dispiace perché il fondo della fiaba ci comunica comunque una solidarietà profonda per il sogno di un bene da raggiungere soprattutto se non si ha avuto nulla o quasi dalla vita. In questa parabola quasi nera sono concentrati tanti temi che avranno un notevole sviluppo nella cinematografia italiana: il paesaggio padano, la strada, il circo, la speranza della fortuna che si conclude con la solidarietà in una lotta comune contro la miseria. La mano dello sceneggiatore e della regia sanno essere sobrie, essenziali e con un tocco incantato che ci sollecita il ricordo della "La strada" e "Miracolo a MIlano" per citare due riferimenti. I piani larghi e morbidi vengono preferiti ai primi piani che avrebbero drammatizzato eccessivamente la storia, proprio per non uscire troppo dalla coralità del racconto, interrotti sono misurati, e dove, pur controllati, riescono a infonderci quel coinvolgimento emotivo nonostante le inverosimili ingenuità. Un cinema che forse non si può fare più, non solo per il paesaggio naturale ma per quello umano, incapace di esprimere un incanto così fuori stagione della vita, quand'è oltre l'infanzia com'è la vecchiaia, o forse si?
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=dCqVt6diYtA&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=9
La lezione di Chaplin è straordinariamente assimilata e tradotta in un soggetto tutto italiano e di originale impatto visivo. La sceneggiatura riesce a modellare i caratteri dei personaggi così bene che gli stessi ci appaiono vicini, confidenziali; ne condividiamo l'umanità anche se non ci riconosciamo nelle ingenuità, ma questa potrebbe essere la cosa che più ci dispiace perché il fondo della fiaba ci comunica comunque una solidarietà profonda per il sogno di un bene da raggiungere soprattutto se non si ha avuto nulla o quasi dalla vita. In questa parabola quasi nera sono concentrati tanti temi che avranno un notevole sviluppo nella cinematografia italiana: il paesaggio padano, la strada, il circo, la speranza della fortuna che si conclude con la solidarietà in una lotta comune contro la miseria. La mano dello sceneggiatore e della regia sanno essere sobrie, essenziali e con un tocco incantato che ci sollecita il ricordo della "La strada" e "Miracolo a MIlano" per citare due riferimenti. I piani larghi e morbidi vengono preferiti ai primi piani che avrebbero drammatizzato eccessivamente la storia, proprio per non uscire troppo dalla coralità del racconto, interrotti sono misurati, e dove, pur controllati, riescono a infonderci quel coinvolgimento emotivo nonostante le inverosimili ingenuità. Un cinema che forse non si può fare più, non solo per il paesaggio naturale ma per quello umano, incapace di esprimere un incanto così fuori stagione della vita, quand'è oltre l'infanzia com'è la vecchiaia, o forse si?
Ho una moglie pazza, pazza, pazza 1964 di Jean Boyer
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=fGdXVwNDs1A&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=11
Film divertente e godibile con sfumature di comicità che non diventano mai eccessive strabordanti conferendo alla storia una leggerezza nonostante il tema impegnativo della psicoanalisi. Tutti i protagonisti sono molto calati nella loro parte ma Fernandel e la Milo superlativi per la spigliatezza della recitazione. Sandra Milo è deliziosa, con una capacità espressiva appropriata e di piccoli gesti, credibilissima, che le conferiscono comunque una latente seduzione e appeal. La carica erotica esploderà nel finale; uno spogliarello collettivo in casa dei protagonisti dove sono stati invitati dal marito di Elen tutti gli amici e impiegate dello stabilimento. Una trovata che consegna alla sceneggiature quel desiderio di anticonformismo sociale molto urgente in quegli anni nella cultura occidentale; psicoanalisi, coppia aperta, sessualità di gruppo, tutte istanze sentite come esperienze liberatorie di una nevrosi delle relazioni e delle regole sociali. Il film è girato tutto in interni tranne che per l'apertura in strada dove la protagonista arriva e parcheggia la sua macchina davanti al palazzo dello psicanalista. L'andatura della Milo nell'attraversare la strada e il gesticolare compulsivo quando sarà difronte a colloquio con il dottore sono una vera grazia di simpatia se non fosse per la serietà del tema che la narrazione sta disvelando. Il tono dello psicanalista ci rende subito la misura dell'esagerazione e ci incute immediatamente il sospetto di un interesse privato dello stesso medico verso le sue pazienti. Eppure avvertiamo subito uno scarto tra l'immediatezza espressiva della protagonista e l'affettazione del medico. Credo che si debba attribuire questo livello di espressività alla bravura della Milo che scende sempre in fondo alla sua parte e ne sa cogliere quelle poche sfumature che fanno il personaggio richiesto dal soggetto e dalla sceneggiatura. Riesce a sviluppare i suoi tentativi maldestri di terapia indotta dai suggerimenti del dottore con meticolosa determinazione con una leggerezza e simpatia anche quando le richieste si fanno audaci e trasgressive, ciò perché ne ha colto il respiro vagamente surreale pur non eccedente in stramberie sceniche di effetti speciali o altre intromissioni di simbologie. Un tocco di anticonformismo che si esprime in una credibile seduzione domestica, in fondo non particolarmente hot, il denudamento degli amici sostenuto e architettato dal marito, Fernandel, quanto il suo spogliarello, punitivo nei confronti del coniuge che voleva irriderla sulla sua presunta pazzia. Lei, la protagonista Sandra Milo, riesce ad essere con pochi gesti seducente anche in uno spogliarello invisibile perché capace di caricarne la sequenza con un'improvviso suspance domestico e allegro; e proprio per questo fine. I due attori principali sono una coppia molto ben riuscita, ciò conferisce alla storia un'attenzione senza momenti vuoti e al film una godibile naturalezza. Il b/n anche se visto con gli occh di oggi è molto godibile, la fotografia è chiara, senza particolari ombre o contrasti e i set di ripresa sono davvero ridotti a poco; nel badget i costi di produzione più alti saranno stati i cachet dei protagonisti. Nel filo d'ironia sotteso che attraversa tutta la storia sembra di risentire le varianti del cinema francese, quel suo fermarsi su un soggetto minuto, un dettaglio della nostra vita e scoprirne che a partire da questo si può raccontare un mondo.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=fGdXVwNDs1A&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=11
Film divertente e godibile con sfumature di comicità che non diventano mai eccessive strabordanti conferendo alla storia una leggerezza nonostante il tema impegnativo della psicoanalisi. Tutti i protagonisti sono molto calati nella loro parte ma Fernandel e la Milo superlativi per la spigliatezza della recitazione. Sandra Milo è deliziosa, con una capacità espressiva appropriata e di piccoli gesti, credibilissima, che le conferiscono comunque una latente seduzione e appeal. La carica erotica esploderà nel finale; uno spogliarello collettivo in casa dei protagonisti dove sono stati invitati dal marito di Elen tutti gli amici e impiegate dello stabilimento. Una trovata che consegna alla sceneggiature quel desiderio di anticonformismo sociale molto urgente in quegli anni nella cultura occidentale; psicoanalisi, coppia aperta, sessualità di gruppo, tutte istanze sentite come esperienze liberatorie di una nevrosi delle relazioni e delle regole sociali. Il film è girato tutto in interni tranne che per l'apertura in strada dove la protagonista arriva e parcheggia la sua macchina davanti al palazzo dello psicanalista. L'andatura della Milo nell'attraversare la strada e il gesticolare compulsivo quando sarà difronte a colloquio con il dottore sono una vera grazia di simpatia se non fosse per la serietà del tema che la narrazione sta disvelando. Il tono dello psicanalista ci rende subito la misura dell'esagerazione e ci incute immediatamente il sospetto di un interesse privato dello stesso medico verso le sue pazienti. Eppure avvertiamo subito uno scarto tra l'immediatezza espressiva della protagonista e l'affettazione del medico. Credo che si debba attribuire questo livello di espressività alla bravura della Milo che scende sempre in fondo alla sua parte e ne sa cogliere quelle poche sfumature che fanno il personaggio richiesto dal soggetto e dalla sceneggiatura. Riesce a sviluppare i suoi tentativi maldestri di terapia indotta dai suggerimenti del dottore con meticolosa determinazione con una leggerezza e simpatia anche quando le richieste si fanno audaci e trasgressive, ciò perché ne ha colto il respiro vagamente surreale pur non eccedente in stramberie sceniche di effetti speciali o altre intromissioni di simbologie. Un tocco di anticonformismo che si esprime in una credibile seduzione domestica, in fondo non particolarmente hot, il denudamento degli amici sostenuto e architettato dal marito, Fernandel, quanto il suo spogliarello, punitivo nei confronti del coniuge che voleva irriderla sulla sua presunta pazzia. Lei, la protagonista Sandra Milo, riesce ad essere con pochi gesti seducente anche in uno spogliarello invisibile perché capace di caricarne la sequenza con un'improvviso suspance domestico e allegro; e proprio per questo fine. I due attori principali sono una coppia molto ben riuscita, ciò conferisce alla storia un'attenzione senza momenti vuoti e al film una godibile naturalezza. Il b/n anche se visto con gli occh di oggi è molto godibile, la fotografia è chiara, senza particolari ombre o contrasti e i set di ripresa sono davvero ridotti a poco; nel badget i costi di produzione più alti saranno stati i cachet dei protagonisti. Nel filo d'ironia sotteso che attraversa tutta la storia sembra di risentire le varianti del cinema francese, quel suo fermarsi su un soggetto minuto, un dettaglio della nostra vita e scoprirne che a partire da questo si può raccontare un mondo.
La visita 1963 di Antonio Pietrangeli
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=uG1O9WnTSEY&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=12
Sandra Milo è la donna e femmina con quelle rotondità piene che in un uomo sarebbero superflue e dannose. Federico Fellini lo aveva inteso nel profondo, facendo riemergere dall'infanzia, il tepore e il fiato che la donna madre, ma anche amore edipico inconsapevole, ci soffia al principio del nostro viaggio; e quel fiato che noi restituiamo nel primo innamoramento, nell'amore da adulti e nel sesso. Questa era una considerazione che mi stava a cuore e colgo qui l'occasione per scriverla prima di queste note di commento sul film "La visita". Un'opera che non ricordavo di aver visto quando ero ragazzo, film che mi era sfuggito o forse semplicemente è uscito fuori dal circuito delle sale e dei palinsesti televisivi. Una bellissima sorpresa questa intensa opera, magistralmente interpretata, su un soggetto anticipatore con una sceneggiatura assolutamente credibile e attuale nei suoi temi profondi: la relazione amorosa, l'indipendenza e la solitudine. Una storia senza sentimentalismi, asciutta dove la miseria maschile emerge nella sua crudezza di costume sociale e l'amore istituzionale ne esce sonoramente bastonato. Entrambi hanno un'amante o per così dire relazione di piacere passeggera e disimpegnata carica di quel momento che al desiderio si accompagna al sesso. La Milo è di un'aderenza al personaggio così profonda che stentiamo a pensarla recitare; la sua mimica e i gesti così femminei costituiscono l'intenso campionario psicologico e sociale che era certo negli intenti narrativi e artistici sia dei soggettisti che del Pietrangeli regista. Il volto di quest'attrice che ricorda quello di una bambina carica ancora di più il personaggio passionale che secondo il costume sociale deve regolare la sua vita normizzare i suoi istinti. Credo che questo contrasto fisiognomico della Milo sia stato un elemento fisico molto presente nel suo successo di carriera fin dalle scelte di Fellini, anzi soprattutto con lui. Una delle pochissime attrici che ha saputo conservare il sesso della bambina nella donna adulta. Questa meta difficile è riuscita perfettamente in questo film comunque amaro per i limiti di una società conformista e ipocrita. Il ritmo visivo è perfetto; l'alternanza degli interni con gli esterni sempre motivata, forse si poteva stare su primissimi piani più intensi con la protagonista ma credo che l'autore fosse un poco tentato di scivolare nella Commedia o almeno ne temeva il rischio. Il b/n riesce a suggerire il colore della protagonista i suoi passaggi emotivi nel corso delle sequenze. Gioca a essere desiderabile fin dalla prima scena dello specchio in stazione e quella finzione del dialogo fuori scena; l'impronta di stile che riuscirà a tenere sospesa la tensione in tutto il film. Insomma la Milo è nel film giusto e questo per un'attrice e molto importante; nella sua naturalezza ha saputo essere un tipo come le arti performative richiedono e soprattutto lo richiede la narrazione nello spettacolo; ma ciò che più ci seduce di lei è questa grande capacità di incassare i colpi della vita, ne era maestra anche la Magnani con una figura di drammatica sopportazione, mentre in Sandra Milo c'è una solarità che ci disorienta per la forza di carattere e nello stesso tempo ci seduce completamente per la sua continua rinascita del sorriso e dell'allegria.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=uG1O9WnTSEY&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=12
Sandra Milo è la donna e femmina con quelle rotondità piene che in un uomo sarebbero superflue e dannose. Federico Fellini lo aveva inteso nel profondo, facendo riemergere dall'infanzia, il tepore e il fiato che la donna madre, ma anche amore edipico inconsapevole, ci soffia al principio del nostro viaggio; e quel fiato che noi restituiamo nel primo innamoramento, nell'amore da adulti e nel sesso. Questa era una considerazione che mi stava a cuore e colgo qui l'occasione per scriverla prima di queste note di commento sul film "La visita". Un'opera che non ricordavo di aver visto quando ero ragazzo, film che mi era sfuggito o forse semplicemente è uscito fuori dal circuito delle sale e dei palinsesti televisivi. Una bellissima sorpresa questa intensa opera, magistralmente interpretata, su un soggetto anticipatore con una sceneggiatura assolutamente credibile e attuale nei suoi temi profondi: la relazione amorosa, l'indipendenza e la solitudine. Una storia senza sentimentalismi, asciutta dove la miseria maschile emerge nella sua crudezza di costume sociale e l'amore istituzionale ne esce sonoramente bastonato. Entrambi hanno un'amante o per così dire relazione di piacere passeggera e disimpegnata carica di quel momento che al desiderio si accompagna al sesso. La Milo è di un'aderenza al personaggio così profonda che stentiamo a pensarla recitare; la sua mimica e i gesti così femminei costituiscono l'intenso campionario psicologico e sociale che era certo negli intenti narrativi e artistici sia dei soggettisti che del Pietrangeli regista. Il volto di quest'attrice che ricorda quello di una bambina carica ancora di più il personaggio passionale che secondo il costume sociale deve regolare la sua vita normizzare i suoi istinti. Credo che questo contrasto fisiognomico della Milo sia stato un elemento fisico molto presente nel suo successo di carriera fin dalle scelte di Fellini, anzi soprattutto con lui. Una delle pochissime attrici che ha saputo conservare il sesso della bambina nella donna adulta. Questa meta difficile è riuscita perfettamente in questo film comunque amaro per i limiti di una società conformista e ipocrita. Il ritmo visivo è perfetto; l'alternanza degli interni con gli esterni sempre motivata, forse si poteva stare su primissimi piani più intensi con la protagonista ma credo che l'autore fosse un poco tentato di scivolare nella Commedia o almeno ne temeva il rischio. Il b/n riesce a suggerire il colore della protagonista i suoi passaggi emotivi nel corso delle sequenze. Gioca a essere desiderabile fin dalla prima scena dello specchio in stazione e quella finzione del dialogo fuori scena; l'impronta di stile che riuscirà a tenere sospesa la tensione in tutto il film. Insomma la Milo è nel film giusto e questo per un'attrice e molto importante; nella sua naturalezza ha saputo essere un tipo come le arti performative richiedono e soprattutto lo richiede la narrazione nello spettacolo; ma ciò che più ci seduce di lei è questa grande capacità di incassare i colpi della vita, ne era maestra anche la Magnani con una figura di drammatica sopportazione, mentre in Sandra Milo c'è una solarità che ci disorienta per la forza di carattere e nello stesso tempo ci seduce completamente per la sua continua rinascita del sorriso e dell'allegria.
Acque di primavera 1942 di Nunzio Malasomma
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=Xb65dEHU2iE&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=13
Un film bianco da restaurare per il sonoro asincrono delle voci. Le nevi e il bianco dei camici dei medici dominano la fotografia di scena. Eppure con il passare delle sequenze e lo svolgersi della storia ci avvediamo che quel bianco è una metafora; e sta per quel sentimento, l'amore, che viene sacrificato piuttosto che mentito. La storia non sembra presentarsi, alle prime battute, con una grande né originale sceneggiatura, ciononostante il film riesce a tenere insieme molti momenti di tensione e alcuni temi che c'incutono, oggi, una certa nostalgia per la lontananza dei comportamenti e del linguaggio. I bambini, rafforzano quel bianco citato prima, con la loro innocenza e comunque inconsapevole partecipazione delle storie d'amore dei grandi. Il cast degli attori riesce in una amalgama anche se non presenta eccellenti momenti di recitazione, anzi purtroppo in gran parte un poco ingessata, difficile da dire se richiesta dal regista oppure difficoltà di calarsi nel personaggio. I ruoli maschili di Cervi e Stoppa sono di certo i più brillanti mentre quelli femminili troppo contenuti con poche sfumature emozionali; forse Anna, l'assistente del dottore, riesce a comunicare le dinamiche del suo innamoramento e del suo cuore. Niente da sottolineare sulla fotografia né sulle inquadrature dei piani, omologate con un montaggio piuttosto scontato, anche se vanno rilevati colpi riusciti di cinematografica narrazione, nonostante il tema sentimentale (oggi si direbbe con qualche sdolcinatura) azzeccati, come la chiusa del film sulla discesa con gli sci di Francesco. Il dottore si precipita a raggiungere l'assistente, la dottoressa Anna che lo ha amato in silenzio, e il cartello fine sapientemente scende prima che i due si incontrino. Questa ricostruzione di montaggio, da un fotogramma assente ma immaginabile, rafforza l'intero film e sceneggiatura. La sorpresa del ritrovamento pur essendo un classico presenta un suo lato inconsueto: l'ambiente montagna e la simbologia della neve. Impegnativo il set di ripresa con i mezzi di allora in esterni che non mancano di curiosità e strappano un sorriso. I tratti rafforzano quella disponibilità a un sentimento di generosità che è la chiave del soggetto e del film. La carrellata sui bambini in costume a prendere il sole in montagna ci svelano d'un colpo qualcosa che non avevamo afferrato con compitezza: i bambini sono in un sanatorio e perciò in cura, seppur malati la loro anima è quella bianca degli"angeli" di questa storia? Proviamo, oggi, una certa tenerezza alle sequenze che descrivono la vita dei bambini in quell'ospedale, per quanto inverosimile, cogliamo comunque delle atmosfere e delle situazioni che non esistono più, una ingenuità d'infanzia così preziosa che ci sembra di aver perduto qualcosa nel tempo e per sempre. La parabola dell'amore perduto e ritrovato è sintetizzata nella narrazione con i due matrimoni nello stesso tempo apertura e confine: il primo che si apre con una carrellata dai cantori bambini ai due sposi per concludersi dopo l'intero svolgimento della narrazione con un matrimonio che seguiamo sulla neve anche se non ne vediamo il rito, la funzione, ma il bianco del paesaggio ne esalta lo spirito e la promessa. Un dramma da camera molto composto, forse un po' viziato da una recitazione troppo didascalica che trattiene la mano alle sequenze drammatiche raccontate con troppo distacco. Ci aiuta quel mondo a capire il nostro di oggi? Forse si, proprio per questa ingenuità insistita come tentativo e necessità di descrivere un sentimento di purezza con poche battute in una chiave sociale che ci ispira nostalgia ma anche profonda e quasi sofferente estraneità. A conclusione degli intenti più riusciti e quelli meno riusciti possiamo dire, toccati, che il film riesce a sciogliere in noi "acque di primavera".
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=Xb65dEHU2iE&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=13
Un film bianco da restaurare per il sonoro asincrono delle voci. Le nevi e il bianco dei camici dei medici dominano la fotografia di scena. Eppure con il passare delle sequenze e lo svolgersi della storia ci avvediamo che quel bianco è una metafora; e sta per quel sentimento, l'amore, che viene sacrificato piuttosto che mentito. La storia non sembra presentarsi, alle prime battute, con una grande né originale sceneggiatura, ciononostante il film riesce a tenere insieme molti momenti di tensione e alcuni temi che c'incutono, oggi, una certa nostalgia per la lontananza dei comportamenti e del linguaggio. I bambini, rafforzano quel bianco citato prima, con la loro innocenza e comunque inconsapevole partecipazione delle storie d'amore dei grandi. Il cast degli attori riesce in una amalgama anche se non presenta eccellenti momenti di recitazione, anzi purtroppo in gran parte un poco ingessata, difficile da dire se richiesta dal regista oppure difficoltà di calarsi nel personaggio. I ruoli maschili di Cervi e Stoppa sono di certo i più brillanti mentre quelli femminili troppo contenuti con poche sfumature emozionali; forse Anna, l'assistente del dottore, riesce a comunicare le dinamiche del suo innamoramento e del suo cuore. Niente da sottolineare sulla fotografia né sulle inquadrature dei piani, omologate con un montaggio piuttosto scontato, anche se vanno rilevati colpi riusciti di cinematografica narrazione, nonostante il tema sentimentale (oggi si direbbe con qualche sdolcinatura) azzeccati, come la chiusa del film sulla discesa con gli sci di Francesco. Il dottore si precipita a raggiungere l'assistente, la dottoressa Anna che lo ha amato in silenzio, e il cartello fine sapientemente scende prima che i due si incontrino. Questa ricostruzione di montaggio, da un fotogramma assente ma immaginabile, rafforza l'intero film e sceneggiatura. La sorpresa del ritrovamento pur essendo un classico presenta un suo lato inconsueto: l'ambiente montagna e la simbologia della neve. Impegnativo il set di ripresa con i mezzi di allora in esterni che non mancano di curiosità e strappano un sorriso. I tratti rafforzano quella disponibilità a un sentimento di generosità che è la chiave del soggetto e del film. La carrellata sui bambini in costume a prendere il sole in montagna ci svelano d'un colpo qualcosa che non avevamo afferrato con compitezza: i bambini sono in un sanatorio e perciò in cura, seppur malati la loro anima è quella bianca degli"angeli" di questa storia? Proviamo, oggi, una certa tenerezza alle sequenze che descrivono la vita dei bambini in quell'ospedale, per quanto inverosimile, cogliamo comunque delle atmosfere e delle situazioni che non esistono più, una ingenuità d'infanzia così preziosa che ci sembra di aver perduto qualcosa nel tempo e per sempre. La parabola dell'amore perduto e ritrovato è sintetizzata nella narrazione con i due matrimoni nello stesso tempo apertura e confine: il primo che si apre con una carrellata dai cantori bambini ai due sposi per concludersi dopo l'intero svolgimento della narrazione con un matrimonio che seguiamo sulla neve anche se non ne vediamo il rito, la funzione, ma il bianco del paesaggio ne esalta lo spirito e la promessa. Un dramma da camera molto composto, forse un po' viziato da una recitazione troppo didascalica che trattiene la mano alle sequenze drammatiche raccontate con troppo distacco. Ci aiuta quel mondo a capire il nostro di oggi? Forse si, proprio per questa ingenuità insistita come tentativo e necessità di descrivere un sentimento di purezza con poche battute in una chiave sociale che ci ispira nostalgia ma anche profonda e quasi sofferente estraneità. A conclusione degli intenti più riusciti e quelli meno riusciti possiamo dire, toccati, che il film riesce a sciogliere in noi "acque di primavera".
Stasera niente di nuovo 1942 di Mario Mattoli
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=BOi0zFAlArI&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=16
Una fotografia noir e battute taglienti per questo film che è cinema nel cinema oltre tutto quanto già detto nella nota esaustiva di presentazione del curatore del canale. Il soggetto e la sceneggiatura non escono fuori da modelli frequentati ma sono stringenti e condotti con sapiente mano narrativa. Si, possiamo enumerare tanti stimoli stilistici e di atmosfere: il cinema francese, il noir americano, gli ambienti e forse anche i tagli di alcune scene ma c'è qualcosa d'italiano, di struggente nel meccanismo del racconto; che sia la canzone? Possibile, tanto che potrebbe avere per titolo di seconda o occhiello di sottotitolo, (e resteremo in tema, vista la professione de protagonista) "Ma l'amore no" splendida perla del contenuto della vicenda a cui assistiamo. Si perché il punto di vista all'inizio sembra quello del giornalista salvato a Istambul dalla veglia affettuosa proseguita per cinque giorni della protagonista, Maria, là intrattenitrice d'amore per ricchi e cantante, ma più avanti ci accorgiamo che il punto di vista scivola sulla canzone, è lei la protagonista che tiene il filo del racconto. E sapientemente, proprio per seminare questo testimone che, Mattoli ce la ripresenta nel mezzo del film di nuovo sul palcoscenico della finzione che poi non è mai distante dal palcoscenico della vita. E qui che il film mostra la sua matura capacità di stare in piedi e di sostenere anche il sentimentalismo che ne scaturisce nel finale. Il teatro nel cinema e il cinema nel teatro, filiale di origine antiche nella nostra cultura di avanspettacolo e di letteratura e melodia. Non c'è che dire tutto quanto al giusto posto e tempi di scena con magistrali primi piani su Maria, Alida Valli che è una perla, così calata nella parte che forse lei stessa si è commossa; o almeno vogliamo crederlo, soprattutto nella sequenza dell'esibizione in teatro, quando il doppiaggio va in asincrono, e questo evidente difetto rende più drammatico il senso, ne siamo indulgenti proprio perché l'autore o gli autori ci hanno portato per mano nella finzione del teatro-vita-cinema, mettendo l'una scatolina nell'altra allo stesso modo di come la nostra vita mette i giorni l'uno dentro l'altro. Vedendola la Valli, in queste sequenze, le riconosciamo una sensualità e una iconicità che allora doveva fare uscire di testa gli uomini e comprendiamo il perché; non ha nulla da invidiare alla sue colleghe americane o francesi. Cosa dire sul finale che sembra un po' domestico alla prima impressione poi ripensando al delirio della protagonista, al suo desiderio e al risveglio nella casa che Cesare Manti, aveva affittato per lei; darle una opportunità per scegliere un'altra strada, un'altra vita, ci accorgiamo che ci sta, e di nuovo ci viene proposta quella versione o lettura teatrale che riprende la scena, non solo, ma è rinforzata con una citazione dal melodramma: "la morte di Violetta nella Traviata", anche qui una citazione di analogie e destini. Possiamo dire che è un epilogo teatrale quello a cui siamo chiamati a credere, e pure qui il dominio è della melodia, della canzone, del canto. Siamo presi non solo dalla bontà verso la ragazza che è finita nella prostituzione senza che ne incontriamo i carcerieri ma sicuramente da una certa simpatia per il cronista, avvilito di qualcosa che ci sfugge, forse una storia finita male, quell'Anna alla quale cercava di scrivere dall'hotel di Istambul, o semplicemente da se stesso. Un cinema che non si può fare più è questa, forse, la nostalgia più profonda che ci coglie nella dissolvenza finale in cui, con una genialata, si fa rispondere al redattore che gli chiede l'ultimo pezzo prima di andare in stampa: "con niente di nuovo", mentendo, quando invece tutta la sua vita era cambiata dopo l'incontro con Maria, e si dovrebbe dire reincontro con questa giovane donna, sola, indifesa, sperduta, sofferente e semplicemente bisognosa di amore come tutti; e lui questo lo aveva capito bene. Era questo amore disinteressato che aveva mosso la ragazza a vegliarlo fino all'uscita dal delirio, quattro anni prima, così si era salvato. La vita perduta in cui era caduta non aveva soffocato la generosità, l'empatia verso l'altro. Era stata una lezione per lui, lo aveva aiutato ad uscire anche dalle sue ipocrisie, radicate nel costume sociale, benché pensasse di esserne vaccinato con il suo ostentato franchismo e rasente cinismo. I nostri conduttori anche qui ci prendono per mano portandoci alle battute del dottore a fine storia; un dottore che nella camera a pensione, dove anche il cronista viveva, si circonda di gabbie con uccelli canterini. Eccellente manuale di sottotesto narrativo, di nuovo il testimone-segnale della partitura o del canovaccio della finzione, che ci fa battere il cuore, ci impegna nelle scelte, in cui inserire le battute della vita sia cantate "Ma l'amore no" che talvolta quasi recitate "Stasera niente di nuovo". E la vita andrà avanti con le sue ferite ma anche i suoi incontri inaspettati.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=BOi0zFAlArI&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=16
Una fotografia noir e battute taglienti per questo film che è cinema nel cinema oltre tutto quanto già detto nella nota esaustiva di presentazione del curatore del canale. Il soggetto e la sceneggiatura non escono fuori da modelli frequentati ma sono stringenti e condotti con sapiente mano narrativa. Si, possiamo enumerare tanti stimoli stilistici e di atmosfere: il cinema francese, il noir americano, gli ambienti e forse anche i tagli di alcune scene ma c'è qualcosa d'italiano, di struggente nel meccanismo del racconto; che sia la canzone? Possibile, tanto che potrebbe avere per titolo di seconda o occhiello di sottotitolo, (e resteremo in tema, vista la professione de protagonista) "Ma l'amore no" splendida perla del contenuto della vicenda a cui assistiamo. Si perché il punto di vista all'inizio sembra quello del giornalista salvato a Istambul dalla veglia affettuosa proseguita per cinque giorni della protagonista, Maria, là intrattenitrice d'amore per ricchi e cantante, ma più avanti ci accorgiamo che il punto di vista scivola sulla canzone, è lei la protagonista che tiene il filo del racconto. E sapientemente, proprio per seminare questo testimone che, Mattoli ce la ripresenta nel mezzo del film di nuovo sul palcoscenico della finzione che poi non è mai distante dal palcoscenico della vita. E qui che il film mostra la sua matura capacità di stare in piedi e di sostenere anche il sentimentalismo che ne scaturisce nel finale. Il teatro nel cinema e il cinema nel teatro, filiale di origine antiche nella nostra cultura di avanspettacolo e di letteratura e melodia. Non c'è che dire tutto quanto al giusto posto e tempi di scena con magistrali primi piani su Maria, Alida Valli che è una perla, così calata nella parte che forse lei stessa si è commossa; o almeno vogliamo crederlo, soprattutto nella sequenza dell'esibizione in teatro, quando il doppiaggio va in asincrono, e questo evidente difetto rende più drammatico il senso, ne siamo indulgenti proprio perché l'autore o gli autori ci hanno portato per mano nella finzione del teatro-vita-cinema, mettendo l'una scatolina nell'altra allo stesso modo di come la nostra vita mette i giorni l'uno dentro l'altro. Vedendola la Valli, in queste sequenze, le riconosciamo una sensualità e una iconicità che allora doveva fare uscire di testa gli uomini e comprendiamo il perché; non ha nulla da invidiare alla sue colleghe americane o francesi. Cosa dire sul finale che sembra un po' domestico alla prima impressione poi ripensando al delirio della protagonista, al suo desiderio e al risveglio nella casa che Cesare Manti, aveva affittato per lei; darle una opportunità per scegliere un'altra strada, un'altra vita, ci accorgiamo che ci sta, e di nuovo ci viene proposta quella versione o lettura teatrale che riprende la scena, non solo, ma è rinforzata con una citazione dal melodramma: "la morte di Violetta nella Traviata", anche qui una citazione di analogie e destini. Possiamo dire che è un epilogo teatrale quello a cui siamo chiamati a credere, e pure qui il dominio è della melodia, della canzone, del canto. Siamo presi non solo dalla bontà verso la ragazza che è finita nella prostituzione senza che ne incontriamo i carcerieri ma sicuramente da una certa simpatia per il cronista, avvilito di qualcosa che ci sfugge, forse una storia finita male, quell'Anna alla quale cercava di scrivere dall'hotel di Istambul, o semplicemente da se stesso. Un cinema che non si può fare più è questa, forse, la nostalgia più profonda che ci coglie nella dissolvenza finale in cui, con una genialata, si fa rispondere al redattore che gli chiede l'ultimo pezzo prima di andare in stampa: "con niente di nuovo", mentendo, quando invece tutta la sua vita era cambiata dopo l'incontro con Maria, e si dovrebbe dire reincontro con questa giovane donna, sola, indifesa, sperduta, sofferente e semplicemente bisognosa di amore come tutti; e lui questo lo aveva capito bene. Era questo amore disinteressato che aveva mosso la ragazza a vegliarlo fino all'uscita dal delirio, quattro anni prima, così si era salvato. La vita perduta in cui era caduta non aveva soffocato la generosità, l'empatia verso l'altro. Era stata una lezione per lui, lo aveva aiutato ad uscire anche dalle sue ipocrisie, radicate nel costume sociale, benché pensasse di esserne vaccinato con il suo ostentato franchismo e rasente cinismo. I nostri conduttori anche qui ci prendono per mano portandoci alle battute del dottore a fine storia; un dottore che nella camera a pensione, dove anche il cronista viveva, si circonda di gabbie con uccelli canterini. Eccellente manuale di sottotesto narrativo, di nuovo il testimone-segnale della partitura o del canovaccio della finzione, che ci fa battere il cuore, ci impegna nelle scelte, in cui inserire le battute della vita sia cantate "Ma l'amore no" che talvolta quasi recitate "Stasera niente di nuovo". E la vita andrà avanti con le sue ferite ma anche i suoi incontri inaspettati.
La canzone dell'amore 1930 di Gennaro Righelli
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=5ekiAj_088I&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=17
Intenso e circolare nella narrazione che si apre con una panoramica su Roma e si chiude con una panoramica sulla stessa città. La coppia che dialoga felice nelle inquadrature iniziali sarà la stessa dell'epilogo, Enrico e Lucia due giovani studenti del Conservatorio pieni di promesse reciproche e di sogni d'amore. Sarà "La canzone dell'amore" di Bixio, il sottofondo drammatico dell'incontro fortuito tra i due in un negozio di musica e sala di registrazione, a contrappuntare le scene tra le più belle e intense tra i due protagonisti. Il sonoro è qui tautologico nel proporsi sia come traccia di una prima registrazione filmica che come contenuto simbolico e sottofondo narrativo di una storia potremmo dire musicale. Perfino il bambino, figlio della madre morta della protagonista, e quindi suo fratello, in certe sequenze prende a suonare la trombetta, quelle di cartone assai comuni tra i giocattoli dei bambini e le feste della Piedigrotta e del Carnevale. Anche la recitazione, in alcuni passi troppo marcata di accenti ci tira dentro il filo della sonorità. Non possiamo certo immaginare che effetto sortisse sul pubblico. A noi oggi ci sembra mal tradotta e asincrona; eppure la finzione non ci disturba più di tanto perché i due protagonisti riescono credibili e soprattutto Lucia, l'attrice che diverrà popolare, Paola Dria, riesce ad attrarre il nostro affetto per lei. La rinuncia al suo futuro e alla sua felicità per osservare l'ultimo desiderio della madre ce la rende in simpatia, fragile, vulnerabile ma generosa e piena d'amore. Da una canzone per l'innamorato ad una canzone per un bambino rimasto orfano che in fondo è suo fratello. Il comportamento protettivo e l'istinto materno l'accompagnano per tutto il lungometraggio; Lucia sarà pronta a sacrificarsi ancora una volta quando, dopo due anni, il padre del bambino, pentito, si fa vivo ritrovandola in casa della donna che l'ha accolta senza riserve. Ed anche qui abbiamo prove di recitazione fortemente coinvolgenti come il pianto che le scoppia, raggomitolata sul pavimento del terrazzo singhiozzante, al pensiero di doversi separare dal piccolo Nini. I diversi cambi di vista e le inclinazioni della camera di ripresa rendono mosso il racconto tra interni ed esterni, forse a volte un poco lunghi e soprattutto instabili, tremolanti. Si nota una ricerca dei cambi di scena e del montaggio, un poco timido in alcuni punti, dovuti ad una impostazione della recitazione secondo modelli del muto ancora troppo vicini per superarli nello stile filmico e che ben conosceva il regista, Righelli che aveva recitato nel muto e aveva avuto un'esperienza tedesca per poi ritornare in Italia. Questa novella di Pirandello è una delle tante tradotte nel linguaggio cinematografico e in una certa misura ne percepiamo a tratti lo spirito. La goliardia iniziale della scolaresca di studenti universitari e musicisti c'introduce senza mezze misure nella storia dei due innamorati che in un certo senso costituisce la parabola del loro destino, soprattutto quando, durante la festa di laurea, ripareranno su un albero per nascondersi dal corteo degli amici che li vuole stuzzicare ed incensare con un rito d'amore goliardico. Bella trovata di sceneggiatura quella dell'albero-nascondiglio d'amore, come quella di farle trovare nel pieno dei suoi progetti di matrimonio con il giovane Enrico (Elio Steiner), un fratellino lasciato orfano, a casa della madre morta e che si presuppone da diversi indizi non tanto più vecchia di lei, diciamo il doppio della sua età, quella di una ragazza di 22 o 23 anni. In tutto il narrato si avverte una lentezzza propria del cinema muto ma anche la rottura che la protagonista sa provocare con la sua drammaturgia, suggerendo di essere seguita con un filo di attento coinvolgimento sia da inquadrature di totali che di primi piani. Il film risulta come registrato in un sottofondo ed anche questa impressione dobbiamo pensarla molto relativa al suo esordio. Così come l'effetto delle vertigini in epilogo, costruito con voluti movimenti di camera nella ripresa sul panorama della città, quando temiamo per il suicidio della giovane che sta per lanciarsi dal terrazzo e viene all'ultimo momento salvata da Enrico che l'afferra giusto un attimo prima. "La canzone dell'amore" è un film contenente tutti gli ingredienti dei soggetti musicali, melò e sentimentali che verranno poi sviluppati nella ricerca del cinema italiano; la stessa drammaturgia del sacrificio femminile e della protezione materna costituiranno interi filoni di soggettistica e sceneggiatura sia formale che a sfondo sociale e documentaristico. Si, "La canzone dell'amore" dobbiamo apprezzarlo come un orgoglio della nostra tradizione musicale italiana e la stessa citazione della Norma volutamente ce lo indica con quella disperazione della Norma a chiare note come lo è per il pianto di Lucia, altro rimando Donizettiano a protagoniste eroine del nostro patrimonio di scena e melodia.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=5ekiAj_088I&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=17
Intenso e circolare nella narrazione che si apre con una panoramica su Roma e si chiude con una panoramica sulla stessa città. La coppia che dialoga felice nelle inquadrature iniziali sarà la stessa dell'epilogo, Enrico e Lucia due giovani studenti del Conservatorio pieni di promesse reciproche e di sogni d'amore. Sarà "La canzone dell'amore" di Bixio, il sottofondo drammatico dell'incontro fortuito tra i due in un negozio di musica e sala di registrazione, a contrappuntare le scene tra le più belle e intense tra i due protagonisti. Il sonoro è qui tautologico nel proporsi sia come traccia di una prima registrazione filmica che come contenuto simbolico e sottofondo narrativo di una storia potremmo dire musicale. Perfino il bambino, figlio della madre morta della protagonista, e quindi suo fratello, in certe sequenze prende a suonare la trombetta, quelle di cartone assai comuni tra i giocattoli dei bambini e le feste della Piedigrotta e del Carnevale. Anche la recitazione, in alcuni passi troppo marcata di accenti ci tira dentro il filo della sonorità. Non possiamo certo immaginare che effetto sortisse sul pubblico. A noi oggi ci sembra mal tradotta e asincrona; eppure la finzione non ci disturba più di tanto perché i due protagonisti riescono credibili e soprattutto Lucia, l'attrice che diverrà popolare, Paola Dria, riesce ad attrarre il nostro affetto per lei. La rinuncia al suo futuro e alla sua felicità per osservare l'ultimo desiderio della madre ce la rende in simpatia, fragile, vulnerabile ma generosa e piena d'amore. Da una canzone per l'innamorato ad una canzone per un bambino rimasto orfano che in fondo è suo fratello. Il comportamento protettivo e l'istinto materno l'accompagnano per tutto il lungometraggio; Lucia sarà pronta a sacrificarsi ancora una volta quando, dopo due anni, il padre del bambino, pentito, si fa vivo ritrovandola in casa della donna che l'ha accolta senza riserve. Ed anche qui abbiamo prove di recitazione fortemente coinvolgenti come il pianto che le scoppia, raggomitolata sul pavimento del terrazzo singhiozzante, al pensiero di doversi separare dal piccolo Nini. I diversi cambi di vista e le inclinazioni della camera di ripresa rendono mosso il racconto tra interni ed esterni, forse a volte un poco lunghi e soprattutto instabili, tremolanti. Si nota una ricerca dei cambi di scena e del montaggio, un poco timido in alcuni punti, dovuti ad una impostazione della recitazione secondo modelli del muto ancora troppo vicini per superarli nello stile filmico e che ben conosceva il regista, Righelli che aveva recitato nel muto e aveva avuto un'esperienza tedesca per poi ritornare in Italia. Questa novella di Pirandello è una delle tante tradotte nel linguaggio cinematografico e in una certa misura ne percepiamo a tratti lo spirito. La goliardia iniziale della scolaresca di studenti universitari e musicisti c'introduce senza mezze misure nella storia dei due innamorati che in un certo senso costituisce la parabola del loro destino, soprattutto quando, durante la festa di laurea, ripareranno su un albero per nascondersi dal corteo degli amici che li vuole stuzzicare ed incensare con un rito d'amore goliardico. Bella trovata di sceneggiatura quella dell'albero-nascondiglio d'amore, come quella di farle trovare nel pieno dei suoi progetti di matrimonio con il giovane Enrico (Elio Steiner), un fratellino lasciato orfano, a casa della madre morta e che si presuppone da diversi indizi non tanto più vecchia di lei, diciamo il doppio della sua età, quella di una ragazza di 22 o 23 anni. In tutto il narrato si avverte una lentezzza propria del cinema muto ma anche la rottura che la protagonista sa provocare con la sua drammaturgia, suggerendo di essere seguita con un filo di attento coinvolgimento sia da inquadrature di totali che di primi piani. Il film risulta come registrato in un sottofondo ed anche questa impressione dobbiamo pensarla molto relativa al suo esordio. Così come l'effetto delle vertigini in epilogo, costruito con voluti movimenti di camera nella ripresa sul panorama della città, quando temiamo per il suicidio della giovane che sta per lanciarsi dal terrazzo e viene all'ultimo momento salvata da Enrico che l'afferra giusto un attimo prima. "La canzone dell'amore" è un film contenente tutti gli ingredienti dei soggetti musicali, melò e sentimentali che verranno poi sviluppati nella ricerca del cinema italiano; la stessa drammaturgia del sacrificio femminile e della protezione materna costituiranno interi filoni di soggettistica e sceneggiatura sia formale che a sfondo sociale e documentaristico. Si, "La canzone dell'amore" dobbiamo apprezzarlo come un orgoglio della nostra tradizione musicale italiana e la stessa citazione della Norma volutamente ce lo indica con quella disperazione della Norma a chiare note come lo è per il pianto di Lucia, altro rimando Donizettiano a protagoniste eroine del nostro patrimonio di scena e melodia.
Assunta Spina 1915 di Francesca Bertini e Gustavo Serena
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=9qVIt4G31JA&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=14
Davvero un capolavoro; tutti giusti i punti e i piani di ripresa e lei, lei sapeva essere un'icona con poco, con quella gestualità naturale che è nel parlato napoletano. Per questo e altri motivi possiamo dire che non c'era nulla di esagerato che cadeva nella parodia come spesso accede nel cinema muto. La misura è straordinaria sia nei piani di costruzione psicologica dei personaggi che nei campi lunghi, descrittivi del paesaggio. Un paesaggio che non si riduceva a cartolina della città ma ne esaltava il temperamento appassionato dei protagonisti. E seppur in b/n la bellezza del territorio ne veniva salvata da una fotografia il cui contrasto dava un vero tocco d'arte alle scenografie di Possilipo, delle marine ed anche delle vie affollate. In certi momenti la fotografia è così intensa nella sua espressività che sembra rimandarci a delle luci caravaggesche, ed anche se non intenzionali come progetto artistico, visto che il critico d'arte Longhi lo riscoprirà più avanti negli anni, quell'atmosfera di ombre e sole tagliante si respira nella pittura del barocco napoletano e negli ambienti stessi della città, nei "vasci", la casa bottega della protagonista. La gestione dei gruppi è veramente sapiente per l'epoca, non dimentichiamo che siamo agli esordi ( il cinema è cominciato nel 1900), risultano così naturali nei movimenti e nelle azioni, senza ammucchiarsi, come la disposizione di una pittura storica. Insomma aveva un occhio formidabile. La sua gestualità, per quanto mobile sobria e asciutta e quasi un alfabeto e il film potrebbe avere un sonoro come da doppiaggio e non si noterebbe l'intrusione. La macchina da presa collocata in casa che riprende l'esterno e l'azione che viene verso il piano medio e quasi in primo piano è di una modernità che ci rende orgogliosi di queste origini del cinema italiano, naturalmente amareggiati di tutto quel materiale che abbiamo perduto per incuria e ignoranza, chissà magari altri capolavori hanno subito questa triste sorte. La storia, assolutamente credibile, antropologicamente di costume, è narrata senza esagerazioni, se ne sente l'aria nelle inquadrature di mare quando sono in barca e l'aria calda del suo fiato quando amoreggia in una veduta dall'alto della città di Napoli. Completo con una nota biografica nel ricordo della mia infanzia ancora c'erano superstiti quelle stirerie con le ragazze e i ferri da stiro a fuoco di carbonelle (quelli di Man Ray, l'artista che vi ha incollato una fila di chiodi), e conoscevo quegli interni per averci giocato in braccio alle stiratrici, sopra i quartieri spagnoli di via Toledo, quando ancora non sapevo delle loro storie d'amore, e chissà, forse negli anni fine cinquanta qualcuna delle più anziane era stata con la Bertini per fare da comparsa o anche solo da consulente e l'aveva vista all'azione così determinata, geniale appassionata con quello scialle bianco avvolgente il suo corpo che era come una bandiera, nonostante tutti i risvolti della vicenda, di purezza di generosità. Grazie per avermi sollecitato un bel ricordo di quegli ambienti, quelle vite e quelle passioni.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=9qVIt4G31JA&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=14
Davvero un capolavoro; tutti giusti i punti e i piani di ripresa e lei, lei sapeva essere un'icona con poco, con quella gestualità naturale che è nel parlato napoletano. Per questo e altri motivi possiamo dire che non c'era nulla di esagerato che cadeva nella parodia come spesso accede nel cinema muto. La misura è straordinaria sia nei piani di costruzione psicologica dei personaggi che nei campi lunghi, descrittivi del paesaggio. Un paesaggio che non si riduceva a cartolina della città ma ne esaltava il temperamento appassionato dei protagonisti. E seppur in b/n la bellezza del territorio ne veniva salvata da una fotografia il cui contrasto dava un vero tocco d'arte alle scenografie di Possilipo, delle marine ed anche delle vie affollate. In certi momenti la fotografia è così intensa nella sua espressività che sembra rimandarci a delle luci caravaggesche, ed anche se non intenzionali come progetto artistico, visto che il critico d'arte Longhi lo riscoprirà più avanti negli anni, quell'atmosfera di ombre e sole tagliante si respira nella pittura del barocco napoletano e negli ambienti stessi della città, nei "vasci", la casa bottega della protagonista. La gestione dei gruppi è veramente sapiente per l'epoca, non dimentichiamo che siamo agli esordi ( il cinema è cominciato nel 1900), risultano così naturali nei movimenti e nelle azioni, senza ammucchiarsi, come la disposizione di una pittura storica. Insomma aveva un occhio formidabile. La sua gestualità, per quanto mobile sobria e asciutta e quasi un alfabeto e il film potrebbe avere un sonoro come da doppiaggio e non si noterebbe l'intrusione. La macchina da presa collocata in casa che riprende l'esterno e l'azione che viene verso il piano medio e quasi in primo piano è di una modernità che ci rende orgogliosi di queste origini del cinema italiano, naturalmente amareggiati di tutto quel materiale che abbiamo perduto per incuria e ignoranza, chissà magari altri capolavori hanno subito questa triste sorte. La storia, assolutamente credibile, antropologicamente di costume, è narrata senza esagerazioni, se ne sente l'aria nelle inquadrature di mare quando sono in barca e l'aria calda del suo fiato quando amoreggia in una veduta dall'alto della città di Napoli. Completo con una nota biografica nel ricordo della mia infanzia ancora c'erano superstiti quelle stirerie con le ragazze e i ferri da stiro a fuoco di carbonelle (quelli di Man Ray, l'artista che vi ha incollato una fila di chiodi), e conoscevo quegli interni per averci giocato in braccio alle stiratrici, sopra i quartieri spagnoli di via Toledo, quando ancora non sapevo delle loro storie d'amore, e chissà, forse negli anni fine cinquanta qualcuna delle più anziane era stata con la Bertini per fare da comparsa o anche solo da consulente e l'aveva vista all'azione così determinata, geniale appassionata con quello scialle bianco avvolgente il suo corpo che era come una bandiera, nonostante tutti i risvolti della vicenda, di purezza di generosità. Grazie per avermi sollecitato un bel ricordo di quegli ambienti, quelle vite e quelle passioni.
Il romanzo di un giovane povero 1942 di Guido Brignone
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=mGxWNHneWUM&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=15
Gentile direttore pubblico qui il mio commento avendo appreso che sul portale di proiezione il film resta per il solo tempo di visione. Spero di non disturbare e ringrazio per il lavoro svolto con passione dal suo canale. Il romanzo di un giovane povero di Guido Brignone 1942 Il bacio finale da manuale in un film da camera nonostante le ambientazione nei campi lunghi del paesaggio che comunque è sempre contenitore d'azione. Non ci sono punti morti o rallentamenti; per un soggetto tratto dalla letteratura è piuttosto un cinema emancipato dalla parola spesso più descrittiva di astrazioni che di azioni. Anche nello sviluppo del soggetto il film presenta una stringatezza dell'intreccio che ci lascia appena il tempo per decidere da che parte stare. Si, questa scelta, può allo stesso tempo dare l'impressione di essere stati troppo sbrigativi delle dinamiche evolutive dei caratteri descritti nella storia. La possibile leggerezza viene risolta brillantemente dal cast degli attori, tutti, ma proprio tutti, il vecchio nonno Ermete Zaccone, Amedeo Nazzari il marchese in segreto, Paolo Stoppa il pretendente in cerca di dote, Margherita la giovane indomabile, sua madre e la bravissima Lina Lattanzi nelle vesti di dama di compagnia di Margherita l'ereditiera. Il ritmo delle sequenze con poche dissolvenze e molti stacchi ce lo rende quasi attuale nel linguaggio, se non fosse per una troppo parsimonia dei primissimi piani, tranne pochissimi momenti, come quello della mano di Margherita che stringe la maniglia della porta di Massimo per uscire dalla sua camera e il protagonista gliela stringe chiudendo la sequenza prima nella stretta e poi contatto delle guance che scivola nel bacio di quel cinema definito"strappalacrime" ma che pur riesce a farsi seguire con benevolenza e partecipazione nonostante le situazioni sociali siano notevolmente cambiate. Perché allora ne siamo attratti? La prima motivazione strettamente legata a linguaggio del cinema: è che gli attori sono molto credibili, la seconda è la morale dell'amore; a questa noi concediamo il tempo trascorso e i costumi passati conservando e condividendo l'onestà, benché romanzesca che si eleva finanche nella morte del vecchio corsaro. Se vogliamo segnalare qualche spunto abbozzato del tempo, è, credo, nel sonoro, troppo poco accennato, mancante di un tema guida, pur riconoscendo la scelta della Traviata un ottimo spunto per rinforzare l'inconsueto del racconto o almeno la trasgressione del costume; ma qui Margherita non deve espiare nessuna colpa, anzi deve convincersi di una verità a cui avrebbe rinunciato per difesa e non per generosità. La generosità qui è del marchese, è del giovane povero. Insomma, quel che si direbbe un polpettone, riesce a strapparci dei sorrisi e anche limitate commozioni, perché come si diceva in esordio, il meccanismo della narrazione non si inceppa mai; controcampi, movimenti di camera per i diversi punti di vista degli ambienti e i totali si seguono con complice empatia, e, seppur sappiamo in anticipo che il finale è scontato, accresciamo nell'intimo turbamento, quel percorso di ostacoli e svelamenti tra le ragioni della mente e le motivazioni del cuore; forse è proprio questa dualità dei conflitti e contraddizioni il nocciolo che ci spiega la rinnovabilità di un rapimento piacevolmente subìto: assistere alla vicenda fortunosa di un giovane ricco che diventa povero per poi di nuovo ritrovarsi ricco sia di beni ereditati che dell'amore. Il sogno che chiediamo alla vita ma anche al cinema?
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=mGxWNHneWUM&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=15
Gentile direttore pubblico qui il mio commento avendo appreso che sul portale di proiezione il film resta per il solo tempo di visione. Spero di non disturbare e ringrazio per il lavoro svolto con passione dal suo canale. Il romanzo di un giovane povero di Guido Brignone 1942 Il bacio finale da manuale in un film da camera nonostante le ambientazione nei campi lunghi del paesaggio che comunque è sempre contenitore d'azione. Non ci sono punti morti o rallentamenti; per un soggetto tratto dalla letteratura è piuttosto un cinema emancipato dalla parola spesso più descrittiva di astrazioni che di azioni. Anche nello sviluppo del soggetto il film presenta una stringatezza dell'intreccio che ci lascia appena il tempo per decidere da che parte stare. Si, questa scelta, può allo stesso tempo dare l'impressione di essere stati troppo sbrigativi delle dinamiche evolutive dei caratteri descritti nella storia. La possibile leggerezza viene risolta brillantemente dal cast degli attori, tutti, ma proprio tutti, il vecchio nonno Ermete Zaccone, Amedeo Nazzari il marchese in segreto, Paolo Stoppa il pretendente in cerca di dote, Margherita la giovane indomabile, sua madre e la bravissima Lina Lattanzi nelle vesti di dama di compagnia di Margherita l'ereditiera. Il ritmo delle sequenze con poche dissolvenze e molti stacchi ce lo rende quasi attuale nel linguaggio, se non fosse per una troppo parsimonia dei primissimi piani, tranne pochissimi momenti, come quello della mano di Margherita che stringe la maniglia della porta di Massimo per uscire dalla sua camera e il protagonista gliela stringe chiudendo la sequenza prima nella stretta e poi contatto delle guance che scivola nel bacio di quel cinema definito"strappalacrime" ma che pur riesce a farsi seguire con benevolenza e partecipazione nonostante le situazioni sociali siano notevolmente cambiate. Perché allora ne siamo attratti? La prima motivazione strettamente legata a linguaggio del cinema: è che gli attori sono molto credibili, la seconda è la morale dell'amore; a questa noi concediamo il tempo trascorso e i costumi passati conservando e condividendo l'onestà, benché romanzesca che si eleva finanche nella morte del vecchio corsaro. Se vogliamo segnalare qualche spunto abbozzato del tempo, è, credo, nel sonoro, troppo poco accennato, mancante di un tema guida, pur riconoscendo la scelta della Traviata un ottimo spunto per rinforzare l'inconsueto del racconto o almeno la trasgressione del costume; ma qui Margherita non deve espiare nessuna colpa, anzi deve convincersi di una verità a cui avrebbe rinunciato per difesa e non per generosità. La generosità qui è del marchese, è del giovane povero. Insomma, quel che si direbbe un polpettone, riesce a strapparci dei sorrisi e anche limitate commozioni, perché come si diceva in esordio, il meccanismo della narrazione non si inceppa mai; controcampi, movimenti di camera per i diversi punti di vista degli ambienti e i totali si seguono con complice empatia, e, seppur sappiamo in anticipo che il finale è scontato, accresciamo nell'intimo turbamento, quel percorso di ostacoli e svelamenti tra le ragioni della mente e le motivazioni del cuore; forse è proprio questa dualità dei conflitti e contraddizioni il nocciolo che ci spiega la rinnovabilità di un rapimento piacevolmente subìto: assistere alla vicenda fortunosa di un giovane ricco che diventa povero per poi di nuovo ritrovarsi ricco sia di beni ereditati che dell'amore. Il sogno che chiediamo alla vita ma anche al cinema?
Luce nelle tenebre 1941 di Mario Mattoli
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=VTT4Xb7juSw&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=18
Due splendide donne esaltate con alcuni primi piani davvero iconici; pochi gesti e alcune espressioni per distinguerne il carattere i sentimenti come vuole appunto il tema di Mattoli. Cinema americano? No ma ci va molto vicino nell'asciuttezza del montaggio, anche se a volte con stacchi di cambio parallelo un poco scolastico. La rivalità tra sorelle per un amore è uno dei più classici temi della narrazione, possiamo andare indietro fino a Cenerentola, ma qui si conserva un'empatia fra le sorelle che tiene legato il dramma fino alla fine senza un vero e proprio conflitto, forse questa è la parte più debole della sceneggiatura; una sintesi apprezzabile ma che manca di qualche passaggio sia conflittuale tra le sorelle interpretate dalle due splendide attrici Alida Valli e Clara Calamai, e una breve più graduale catartica sequenza del finale con la riacquistata vista. Ci sorprende la scelta di Giachetti-Alberto, perché non ci sembra aver colto durante la sua cecità quel momento rivelatore che ci possa far comprendere la sua scelta; poi ripensiamo al pianoforte alla sonata che non ricorda e comprendiamo che è lì in quel momento la catarsi tutta contenuta in una drammaturgia borghese direi da camera, teatrale, per alcuni aspetti pirandelliano. Il gioco delle parti è il gioco della vita. Mattoli ha centrato la sonorizzazione e non mi riferisco al volume quanto al montaggio ed è stato bravo nel renderlo anche iconico con la sovra-impressione dell'orologio che seppur un classico entra discretamente a potenziare il battito del cuore di Marina; il cuore che batte per tutto il film fin dal primo momento e noi lo seguiamo, si, il regista è capace di farlo diventare una soggettiva dal momento in cui ne siamo presi guardiamo tutto il resto del mondo che è in quel film dal cuore di Marina. Un soggetto classico rielaborato con efficacia nonostante l'espediente piuttosto banale dello scambio degli oggetti del regalo. "Luce nelle tenebre" è la metafora dell'amore inconsapevole quanto l'esperienza esistenziale e biografica del protagonista ingegnere minerario, scelta pertinentissima per descrivere il profili di un innamorato piuttosto impacciato e a volte con troppi tocchi di ingenuità. Questo è il rischio di film girati nel regime che finivano per soffrire una autocensura se non nei contenuti nello svolgimento di temi. Degli esterni e degli ambienti non ci resta nulla, della grammatica sottolineata del cinema poche cose, forse la ripresa dall'alto delle danze, il carrello sui volti dei dottori quando gli tolgono le bende; ma è nei primi piani che la memoria attiva la sua raccolta per ricevere da essi tutta la carica del sentimento e lasciare a queste due donne la loro forza di farsi immagine in una sceneggiatura anche e significativamente suono quando ad una delle battute iniziali si dice: due donne la stessa voce ma quanto diverse, consegnando allo spettatore e al pubblico, la chiave per aprire quel cuore; e proprio l'ascolto della voce sarà in grado di attivare lontano dalla seduzione dell'immagine, con una verità che si farà luce nelle tenebre della sua cecità e cioè: l'amore.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=VTT4Xb7juSw&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=18
Due splendide donne esaltate con alcuni primi piani davvero iconici; pochi gesti e alcune espressioni per distinguerne il carattere i sentimenti come vuole appunto il tema di Mattoli. Cinema americano? No ma ci va molto vicino nell'asciuttezza del montaggio, anche se a volte con stacchi di cambio parallelo un poco scolastico. La rivalità tra sorelle per un amore è uno dei più classici temi della narrazione, possiamo andare indietro fino a Cenerentola, ma qui si conserva un'empatia fra le sorelle che tiene legato il dramma fino alla fine senza un vero e proprio conflitto, forse questa è la parte più debole della sceneggiatura; una sintesi apprezzabile ma che manca di qualche passaggio sia conflittuale tra le sorelle interpretate dalle due splendide attrici Alida Valli e Clara Calamai, e una breve più graduale catartica sequenza del finale con la riacquistata vista. Ci sorprende la scelta di Giachetti-Alberto, perché non ci sembra aver colto durante la sua cecità quel momento rivelatore che ci possa far comprendere la sua scelta; poi ripensiamo al pianoforte alla sonata che non ricorda e comprendiamo che è lì in quel momento la catarsi tutta contenuta in una drammaturgia borghese direi da camera, teatrale, per alcuni aspetti pirandelliano. Il gioco delle parti è il gioco della vita. Mattoli ha centrato la sonorizzazione e non mi riferisco al volume quanto al montaggio ed è stato bravo nel renderlo anche iconico con la sovra-impressione dell'orologio che seppur un classico entra discretamente a potenziare il battito del cuore di Marina; il cuore che batte per tutto il film fin dal primo momento e noi lo seguiamo, si, il regista è capace di farlo diventare una soggettiva dal momento in cui ne siamo presi guardiamo tutto il resto del mondo che è in quel film dal cuore di Marina. Un soggetto classico rielaborato con efficacia nonostante l'espediente piuttosto banale dello scambio degli oggetti del regalo. "Luce nelle tenebre" è la metafora dell'amore inconsapevole quanto l'esperienza esistenziale e biografica del protagonista ingegnere minerario, scelta pertinentissima per descrivere il profili di un innamorato piuttosto impacciato e a volte con troppi tocchi di ingenuità. Questo è il rischio di film girati nel regime che finivano per soffrire una autocensura se non nei contenuti nello svolgimento di temi. Degli esterni e degli ambienti non ci resta nulla, della grammatica sottolineata del cinema poche cose, forse la ripresa dall'alto delle danze, il carrello sui volti dei dottori quando gli tolgono le bende; ma è nei primi piani che la memoria attiva la sua raccolta per ricevere da essi tutta la carica del sentimento e lasciare a queste due donne la loro forza di farsi immagine in una sceneggiatura anche e significativamente suono quando ad una delle battute iniziali si dice: due donne la stessa voce ma quanto diverse, consegnando allo spettatore e al pubblico, la chiave per aprire quel cuore; e proprio l'ascolto della voce sarà in grado di attivare lontano dalla seduzione dell'immagine, con una verità che si farà luce nelle tenebre della sua cecità e cioè: l'amore.
Fantasmi a Roma 1961 di Antonio Pietrangeli
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=GunYBy6-Ovk&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=21
Eduardo è il mattatore del film; il soggetto e la sceneggiatura sembrano scritte con il suo stile tanto che a volte stentiamo a pensarlo un film e possiamo crederla una ripresa cinematografica di un'opera teatrale. Erano intenzioni di Pietrangeli? Bisognerebbe saperne qualcosa di più su com'è nata l'idea, il soggetto e soprattutto la produzione. Gli attori protagonisti avevano già tutti un nome e riescono a figurare molto egregiamente ciascuno nel proprio ruolo, C'è qualcosa che non si può comprare ed è la propria identità storica, nel bene e nel male finirà per sedurre anche il nipote ereditario della dimora che tenendola per sé ne proseguirà, il casato e la follia.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=GunYBy6-Ovk&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=21
Eduardo è il mattatore del film; il soggetto e la sceneggiatura sembrano scritte con il suo stile tanto che a volte stentiamo a pensarlo un film e possiamo crederla una ripresa cinematografica di un'opera teatrale. Erano intenzioni di Pietrangeli? Bisognerebbe saperne qualcosa di più su com'è nata l'idea, il soggetto e soprattutto la produzione. Gli attori protagonisti avevano già tutti un nome e riescono a figurare molto egregiamente ciascuno nel proprio ruolo, C'è qualcosa che non si può comprare ed è la propria identità storica, nel bene e nel male finirà per sedurre anche il nipote ereditario della dimora che tenendola per sé ne proseguirà, il casato e la follia.
Vestire gli ignudi 1954 di Marcello Pagliero
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=_Umug2t-eLo&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=20
Bellissimo, intenso nella sua semplicità; un capolavoro dimenticato? E.R.Drago è duchessa dello schermo, come veniva chiamata dai suoi fans, una vera mattatrice della narrazione. Naturalmente il soggetto pirandelliano costituisce l'ossatura di fondo della sceneggiatura che si srotola con assoluta consequenzialità. E data l'impostazione della voce fuori campo, che anticipa in fead-back lo svolgimento dei fatti, possiamo riconosce a questo espediente una geniale misura dell'intero stile del film. Ciononostante il silenzio delle "sequenze ricordate" finiscono per aumentare la drammatizzazione e conferiscono una certa surrealtà all'intera storia. Quella surrealtà che è in fondo la cifra dello scrittore siciliano e nel film non depotenzia per nulla la forza realistica dei fatti umani, anzi questi vengono vagliati con profonde riflessioni filosofiche e morali. I dialoghi, pur nella loro essenzialità scenica, conservano la forza drammaturgica della parola del teatro e della vita stessa. Il personaggio di Ersilia concentra il doppio del nostro profilo umano ma anche la fragilità e la debolezza di chi è ingannato per troppa umanità. Il torbido risvolto erotico e sessuale, che lascia intravedere le zone oscure della protagonista, in fondo ne esprime anche tutta la sua umanità e infine direi il conflitto di un accoglienza che la società non riesce ad attivare. Un perdono che non giunge in tempo visto la morte della protagonista a conclusione della storia, come un accidente, un destino, una liberazione, o in una lettura simbolica estrema, addirittura un premio, quello di allontanarsi definitivamente dal mondo dove impera la menzogna. Sono solo uomini, i suoi apparenti salvatori, ma in fondo sono i suoi più feroci aggressori; non la lasciano un istante riprendersi, ritrovarsi, e non le è un vantaggio essere una "bella donna" come commenta il marinaio al commissiariato dove deposita il verbale del soccorso che le ha prestato celermente assieme al noto scrittore, casualmente transitante per il parco. Tanto è misurata la recitazione di Ferzetti, colto da un evento imprevisto nella noiosa relazione con una donna di buona famiglia, quanto è struggente e interna la recitazione della Drago che riesce a gestire una modulazione del suo sviluppo psicologico con eccellente artisticità. Sapiente la scelta del regista di avvicinarsi in primi piani con misura per dare forza e allo stesso tempo grazia al volto della giovane attrice. Non è facile stare così vicino a personaggi che stanno svelandosi, alienati da se stessi, senza far cadere la narrazione del film in una improbabile e a volte più spesso moralistica versione sulle scelte umane. Non lasciarsi sfuggire la mano nella conduzione del ciak è una dote di grande rispetto, e in questo film possiamo certamente dire che è stato raggiunto lo scopo. Per quella scelta del fead-back muto e senza nessun sonoro possiamo quasi affermare che ci sono due film che guardiamo, l'uno nell'altro; entrambi sono la soggettiva della protagonista che splendidamente ha un apparirci diverso, eppure senza maschera, anche quando nel suo volto leggiamo il segno, non lacerato dal dolore, ma in bilico tra la dignità della persona da difendere e la condizione di una seduzione soggiogante di un abuso e ricatto. In queste due donne lacerate è Ersilia; neanche l'incontro di chi avrebbe voluto, lo scrittore in cerca di storie, redimendo la serva, salvare se stesso dall'inedia e dalla viltà, potrà qui mutare il suo destino. Non è bastato quel tentativo, come non potevano cambiarla né il pentimento del fidanzato che l'aveva abbandonata, quanto la proposta di dipendenza fisica, senza alcun sentimento, del padrone di casa che l' aveva poi sedotta, approfittando del suo dolore e delusione. No le due donne non avevano altra possibilità di ricongiungersi, se non fuori dal discorso umano e sociale, conformista, dalla parola stessa corrotta della menzogna, che è la chiave della narrazione intrecciata metaforicamente al giornalista di cronaca. Questi in ospedale le fa un'intervista senza alcun pudore per i sentimenti della donna; e sarà quella parola ch'egli attiverà nel mondo della stampa a costituire il confine perdendosi, mentendo sui fatti, col solo intento di sollecitare la sete più becera del lettore di cronaca nera, nel circuito sociale del discorso e della morale. E in una rinuncia sofferente ma dignitosa la protagonista ci dice che nessuno potrà ritornarle quella parola di verità, solo la morte.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=_Umug2t-eLo&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=20
Bellissimo, intenso nella sua semplicità; un capolavoro dimenticato? E.R.Drago è duchessa dello schermo, come veniva chiamata dai suoi fans, una vera mattatrice della narrazione. Naturalmente il soggetto pirandelliano costituisce l'ossatura di fondo della sceneggiatura che si srotola con assoluta consequenzialità. E data l'impostazione della voce fuori campo, che anticipa in fead-back lo svolgimento dei fatti, possiamo riconosce a questo espediente una geniale misura dell'intero stile del film. Ciononostante il silenzio delle "sequenze ricordate" finiscono per aumentare la drammatizzazione e conferiscono una certa surrealtà all'intera storia. Quella surrealtà che è in fondo la cifra dello scrittore siciliano e nel film non depotenzia per nulla la forza realistica dei fatti umani, anzi questi vengono vagliati con profonde riflessioni filosofiche e morali. I dialoghi, pur nella loro essenzialità scenica, conservano la forza drammaturgica della parola del teatro e della vita stessa. Il personaggio di Ersilia concentra il doppio del nostro profilo umano ma anche la fragilità e la debolezza di chi è ingannato per troppa umanità. Il torbido risvolto erotico e sessuale, che lascia intravedere le zone oscure della protagonista, in fondo ne esprime anche tutta la sua umanità e infine direi il conflitto di un accoglienza che la società non riesce ad attivare. Un perdono che non giunge in tempo visto la morte della protagonista a conclusione della storia, come un accidente, un destino, una liberazione, o in una lettura simbolica estrema, addirittura un premio, quello di allontanarsi definitivamente dal mondo dove impera la menzogna. Sono solo uomini, i suoi apparenti salvatori, ma in fondo sono i suoi più feroci aggressori; non la lasciano un istante riprendersi, ritrovarsi, e non le è un vantaggio essere una "bella donna" come commenta il marinaio al commissiariato dove deposita il verbale del soccorso che le ha prestato celermente assieme al noto scrittore, casualmente transitante per il parco. Tanto è misurata la recitazione di Ferzetti, colto da un evento imprevisto nella noiosa relazione con una donna di buona famiglia, quanto è struggente e interna la recitazione della Drago che riesce a gestire una modulazione del suo sviluppo psicologico con eccellente artisticità. Sapiente la scelta del regista di avvicinarsi in primi piani con misura per dare forza e allo stesso tempo grazia al volto della giovane attrice. Non è facile stare così vicino a personaggi che stanno svelandosi, alienati da se stessi, senza far cadere la narrazione del film in una improbabile e a volte più spesso moralistica versione sulle scelte umane. Non lasciarsi sfuggire la mano nella conduzione del ciak è una dote di grande rispetto, e in questo film possiamo certamente dire che è stato raggiunto lo scopo. Per quella scelta del fead-back muto e senza nessun sonoro possiamo quasi affermare che ci sono due film che guardiamo, l'uno nell'altro; entrambi sono la soggettiva della protagonista che splendidamente ha un apparirci diverso, eppure senza maschera, anche quando nel suo volto leggiamo il segno, non lacerato dal dolore, ma in bilico tra la dignità della persona da difendere e la condizione di una seduzione soggiogante di un abuso e ricatto. In queste due donne lacerate è Ersilia; neanche l'incontro di chi avrebbe voluto, lo scrittore in cerca di storie, redimendo la serva, salvare se stesso dall'inedia e dalla viltà, potrà qui mutare il suo destino. Non è bastato quel tentativo, come non potevano cambiarla né il pentimento del fidanzato che l'aveva abbandonata, quanto la proposta di dipendenza fisica, senza alcun sentimento, del padrone di casa che l' aveva poi sedotta, approfittando del suo dolore e delusione. No le due donne non avevano altra possibilità di ricongiungersi, se non fuori dal discorso umano e sociale, conformista, dalla parola stessa corrotta della menzogna, che è la chiave della narrazione intrecciata metaforicamente al giornalista di cronaca. Questi in ospedale le fa un'intervista senza alcun pudore per i sentimenti della donna; e sarà quella parola ch'egli attiverà nel mondo della stampa a costituire il confine perdendosi, mentendo sui fatti, col solo intento di sollecitare la sete più becera del lettore di cronaca nera, nel circuito sociale del discorso e della morale. E in una rinuncia sofferente ma dignitosa la protagonista ci dice che nessuno potrà ritornarle quella parola di verità, solo la morte.
Catene invisibili 1942 di Mario Mattoli
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=cULKjIEk8C0&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=19
La nebbia di Milano è la condizione di quei sentimenti che stentano a nascere perché offuscati, rimossi dall'inessenziale, dal superfluo, dalla ricchezza. La parabola iniziale della morte improvvisa dell'industriale scoprirà, quei sentimenti, un poco alla volta quando i due protagonisti, il direttore degli stabilimenti, Carlo Danieli e la figlia del proprietario, Elena, si scontreranno nelle loro differenze di visione del mondo ma si specchieranno con similitudine nella solitudine; e sarà questa solitudine confessata che li metterà l'uno nelle braccia dell'altro. La storia è condotta con una sceneggiatura serrata, capace di variare le atmosfere delle sequenze sia degli interni che degli esterni. La nebbia, nella quale scompare la madre del giovane precipitato dal parapetto della sua casa tentando la fuga dalla polizia che lo insegue, rappresenta, simbolicamente in campo lungo, la fine della storia, la sparizione di un passato che è meglio non rivangare come consigliava l'amico di famiglia, Cesare, ago della bilancia della storia, e interpellato da entrambi gli innamorati nei loro momenti di dubbio e di sconforto. Un ruolo che nasce da subito, quando Cesare Tani mostrerà alla protagonista l'album dei ricordi e delle foto che il padre della giovane teneva in custodia, in un prezioso gesto di conservazione e amore. Ecco il primo svelamento dei sentimenti che erano nascosti nella nebbia delle convenzioni e dei fraintendimenti. Non aver saputo cogliere l'occasione di un riscatto per Enrico Leti, fratellastro ignaro della giovane Silvagni rende molto spietata la considerazione di un destino immutabile per chi è nato in una condizione di privazioni, seppure illegittimo ma di paternità facoltosa. Non c'è marcatura in modo realistico su questo aspetto del soggetto che viene lasciato a margine della storia, lontana da insorgenze di senso di colpa o pentimenti parentali. Mattoli vuole comunque spostare, su un epilogo da favola, evitando ogni rischio di cinema psicologico, l'intreccio della storia, cambiando le carte di esordio dei due protagonisti; la giovane viziata e spendacciona che diviene adulta e responsabile mentre il composto ingegnere, Carlo Ninchi, si fa cogliere dal rossore e dall'innamoramento, dalla sorpresa e l'imprevedibile passione. La Valli ha un fascino sia nei suoi momenti di capricci che in quelli di effusioni del cuore, di nascosto innamoramento; anche se svolta in così poco tempo di sviluppo filmico, riusciamo comunque a credere alla trasformazione e alla maturazione dei due innamorati, per un intreccio narrativo focalizzato sull'amico confidente. Il suo volto riesce ad essere iconico e la recitazione convincente sebbene a volte lievemente asincrona. Sono al giusto posto collocati i primi piani sempre espressivi e contrapposti alle scene d'azione, ai movimenti di camera non eccessivi, preferendo gli stacchi un poco americani e sostenuti da un dialogo incisivo, nonostante in visibile doppiaggio e comunque non in presa diretta. La nevrosi di una famiglia borghese non è un soggetto nuovo nella costellazione del cinema, e forse neanche il lieto fine. In questo caso l'impronta di Mattoli traspare, principalmente, mi viene da pensare al finale, un poco sdolcinato, dopo le sequenze notturne delle nebbie della città lombarda; e la scelta sarà del ritrovamento dei due sul piroscafo per Capri ma che fa molto cinema, con una chiusa senza bacio. Un'inquadratura che sentiamo ci manca, e forse non ci credeva neanche il regista e gli sceneggiatori; avrebbe svecchiato il tono troppo impostato dato alla relazione nascente dei due protagonisti. Le età da cinema non convincono, 23 lei e 41 lui, convenzione da spettacolo che allora veniva tralasciata a una verosimiglianza tradita, e che, può rallentare l'entusiasmo della credibilità. Il titolo, per il tipo di storia e l'ambiente descritto non mi sembra molto azzeccato e lascia spazio a una ridondanza, oggi più che allora, avvezzi ad un linguaggio amoroso denso di metafore e coloriture. Da un titolo così ci saremmo aspettati un corpo a corpo, una stretta o almeno quegli schiaffi, tanto desiderati dall'uomo, che pur lanciati nel bel mezzo della compostezza del suo personaggio, alludono ad un certo erotismo e ci fanno capire che il gioco dell'innamoramento sarà negli sguardi nella loro inconfondibile mimica discreta, introversa e borghese, una parabola contraddicente l'esordio focoso ed anticonformista della giovane borghese bella e di buona famiglia.
per guardare il film:
www.youtube.com/watch?v=cULKjIEk8C0&list=PL2KsXt-6_eulJ2NS57Hd7khHOgyrtZbTt&index=19
La nebbia di Milano è la condizione di quei sentimenti che stentano a nascere perché offuscati, rimossi dall'inessenziale, dal superfluo, dalla ricchezza. La parabola iniziale della morte improvvisa dell'industriale scoprirà, quei sentimenti, un poco alla volta quando i due protagonisti, il direttore degli stabilimenti, Carlo Danieli e la figlia del proprietario, Elena, si scontreranno nelle loro differenze di visione del mondo ma si specchieranno con similitudine nella solitudine; e sarà questa solitudine confessata che li metterà l'uno nelle braccia dell'altro. La storia è condotta con una sceneggiatura serrata, capace di variare le atmosfere delle sequenze sia degli interni che degli esterni. La nebbia, nella quale scompare la madre del giovane precipitato dal parapetto della sua casa tentando la fuga dalla polizia che lo insegue, rappresenta, simbolicamente in campo lungo, la fine della storia, la sparizione di un passato che è meglio non rivangare come consigliava l'amico di famiglia, Cesare, ago della bilancia della storia, e interpellato da entrambi gli innamorati nei loro momenti di dubbio e di sconforto. Un ruolo che nasce da subito, quando Cesare Tani mostrerà alla protagonista l'album dei ricordi e delle foto che il padre della giovane teneva in custodia, in un prezioso gesto di conservazione e amore. Ecco il primo svelamento dei sentimenti che erano nascosti nella nebbia delle convenzioni e dei fraintendimenti. Non aver saputo cogliere l'occasione di un riscatto per Enrico Leti, fratellastro ignaro della giovane Silvagni rende molto spietata la considerazione di un destino immutabile per chi è nato in una condizione di privazioni, seppure illegittimo ma di paternità facoltosa. Non c'è marcatura in modo realistico su questo aspetto del soggetto che viene lasciato a margine della storia, lontana da insorgenze di senso di colpa o pentimenti parentali. Mattoli vuole comunque spostare, su un epilogo da favola, evitando ogni rischio di cinema psicologico, l'intreccio della storia, cambiando le carte di esordio dei due protagonisti; la giovane viziata e spendacciona che diviene adulta e responsabile mentre il composto ingegnere, Carlo Ninchi, si fa cogliere dal rossore e dall'innamoramento, dalla sorpresa e l'imprevedibile passione. La Valli ha un fascino sia nei suoi momenti di capricci che in quelli di effusioni del cuore, di nascosto innamoramento; anche se svolta in così poco tempo di sviluppo filmico, riusciamo comunque a credere alla trasformazione e alla maturazione dei due innamorati, per un intreccio narrativo focalizzato sull'amico confidente. Il suo volto riesce ad essere iconico e la recitazione convincente sebbene a volte lievemente asincrona. Sono al giusto posto collocati i primi piani sempre espressivi e contrapposti alle scene d'azione, ai movimenti di camera non eccessivi, preferendo gli stacchi un poco americani e sostenuti da un dialogo incisivo, nonostante in visibile doppiaggio e comunque non in presa diretta. La nevrosi di una famiglia borghese non è un soggetto nuovo nella costellazione del cinema, e forse neanche il lieto fine. In questo caso l'impronta di Mattoli traspare, principalmente, mi viene da pensare al finale, un poco sdolcinato, dopo le sequenze notturne delle nebbie della città lombarda; e la scelta sarà del ritrovamento dei due sul piroscafo per Capri ma che fa molto cinema, con una chiusa senza bacio. Un'inquadratura che sentiamo ci manca, e forse non ci credeva neanche il regista e gli sceneggiatori; avrebbe svecchiato il tono troppo impostato dato alla relazione nascente dei due protagonisti. Le età da cinema non convincono, 23 lei e 41 lui, convenzione da spettacolo che allora veniva tralasciata a una verosimiglianza tradita, e che, può rallentare l'entusiasmo della credibilità. Il titolo, per il tipo di storia e l'ambiente descritto non mi sembra molto azzeccato e lascia spazio a una ridondanza, oggi più che allora, avvezzi ad un linguaggio amoroso denso di metafore e coloriture. Da un titolo così ci saremmo aspettati un corpo a corpo, una stretta o almeno quegli schiaffi, tanto desiderati dall'uomo, che pur lanciati nel bel mezzo della compostezza del suo personaggio, alludono ad un certo erotismo e ci fanno capire che il gioco dell'innamoramento sarà negli sguardi nella loro inconfondibile mimica discreta, introversa e borghese, una parabola contraddicente l'esordio focoso ed anticonformista della giovane borghese bella e di buona famiglia.
La Principessa del sogno (1942) di Maria Teresa Ricci
Per guardare il film :
www.youtube.com/watch?v=bMYdkHj4Q38
Perché bisogna credere alle fiabe? È la battuta che Elisabetta rivolge alle orfanelle nella chiusa del film.
Una conduzione delicata e senza rallentamenti superflui ci tiene sospesi fino al lieto fine ciononostante l’esito ci è noto e la trama pure. Eppure quel sogno, quell’aspirazione, quel desiderio di felicità ci governa come la più semplice passione della vita: l’amore.
La recitazione modulata come in una lettura, la fotografia leggermente sfocata da vecchie lastre di repertorio, finanche l’allestimento fittizio, quasi una scena teatrale che un set cinematografico contribuiscono a sostenere l’atmosfera della narrazione sopra le righe alla universalmente popolare Cenerentola.
Il commento musicale è sapientissimo e riesce a sottolineare gli stati emozionali della protagonista rafforzandone il personaggio fino a disegnarla fortemente iconica nella già angelica sua bellezza. L’inverosimiglianza è così disarmante che siamo disposti a seguire la storia con un sorprendente coinvolgimento non più razionale, da adulti, ma rapiti, appunto nel sogno, come quando si è bambini e la felicità non solo ci sembra a portata di mano quanto ci si presenta ricompensa e diritto della nostra fede della nostra determinazione e fiducia nel prossimo.
Gli esterni e gli interni sono molto concisi e illustrati con lenti movimenti di camera e brevi transiti di dissolvenze che oggi non si monterebbero a rischio di apparire dilettanti. Tutti gli attori recitano citando sé stessi e in un registro teatrale.
È un film conciliante per chi ha ancora un conto aperto verso la vita e l’incontro di un’anima gemella, con tutti gli ingredienti della sceneggiatura e delle inquadrature ben collocate nelle aspettative di un lettore spettatore immerso nell’evasione della vita del sogno e dell’attesa di quel bene che ci fa essere così umani e così vulnerabili.
In breve una eccellente prova di regia di Maria Teresa Ricci dopo aver fatto l’assistente alla regia del maestro Bragaglia in dieci film e la sceneggiatrice segnando anche il primato di essere stata la prima donna italiana nella regia del cinema sonoro. L’essersi ritirata a vita privata ci ha privati di certo di un’autrice di grande sensibilità filmica e acuta narratrice dei costumi sociali.
Stroncato dalla critica alla sua uscita, credo che, invece oggi, si possa leggerne un merito, quello di aver contrappuntato la durezza e anche tragicità del periodo bellico con una evasione surrealista che in qualche modo si presenta onesta senza retorica come deve esserlo per una fiaba in fondo nata dalla vita.
Campane a martello (1949) regia di Luigi Zampa
Per guardare il film:
https://www.youtube.com/watch?v=-9Zktj0k-LA
Una sceneggiatura circolare per un film che ci ricorda la stagione neorealista.
Comincerei dalle due sapienti inquadrature nella sequenza di apertura e nella sequenza di chiusura: la nave con gli ultimi soldati americani che parte dal porto di Napoli e le due protagoniste a salutare con i fazzoletti questi giovani, che seppur non sono stati amori di una vita socialmente riconosciuta, sono stati comunque amori della vita; e la vita non guarda in faccia a nessuno nel suo farsi, chiedere e dare. Si impone nello scorrere della storia e travolge la cronaca di chiunque nel bene e nel male.
Possiamo sperare, si, possiamo desiderare di migliorarci e perfino di essere altro dalla nostra identità dal nostro passato.
Ecco le due donne, Sanson e la Lollobrigida, immerse nella folla delle altre donne sul pontile del porto, stanno salutando il loro passato e quei fazzoletti bianchi possono essere una “resa” a ciò che è stato e allo stesso tempo, il foglio bianco, puro su cui poter scrivere il proprio futuro, in una nuova identità con una nuova vita.
Non certo ragazze leggere, che si accompagnavano ai giovani militari d’oltre oceano, ma offerte della guerra ai vincitori, in quella dinamica che è storia della nostra civiltà, tra dominanti e dominati, non solo nelle classi sociali, ma anche nella linea evolutiva dell’antropologia e dei paradigmi sociali tra il maschile e il femminile. Un prezzo di guerra seppure taciuto e passato nel clima dei liberatori dei salvatori dell’Italia. Ma quelle vite consegnate all’occupazione di truppe militari si volgono e in cuor loro sperano a una rinascita, anche per la loro giovane età, a una felicità possibile.
Potremmo dire che il film è in tutte e due queste sequenza di una sceneggiatura scorrevole senza incredulità, credibile, anche se lo scarto tra le protagoniste attrici e il resto degli abitanti veri dell’isola d’Ischia a volte emerge un poco costruito nei toni e nell’assenza di momenti di interazione reale; diciamo che sono state usate come masse e contrappunti di campi lunghi per dare quel tanto di movimento alla storia di Agostina da non farla cadere in una narrazione psicologica e tenerla sempre sospesa al filo di un contesto e di un ambiente popolare, di un realismo.
Queste due scene con gru e controcampi trovo che siano un manifesto di stile di Zampa, il suo modo di entrare nel racconto da un insieme che è anche un contenuto da svelare, un’immagine da scoprire.
In questo scorrere lineare, senza troppi salti, della vicenda, il commento sonoro riesce a sostenere le immagini con delicate sfumature di commento sempre accorto, mai invadente.
La storia è semplice: All’identificazione della polizia, le due giovani donne ricevono un foglio di via. Agostina è obbligata a ritornare alla sua isola: Ischia. Non vorrebbe, non saprebbe come giustificarsi della vita condotta e solo sull’insistenza all’obbedienza del commissario si rassegna.
Ha inviato dei soldi al prete che glieli custodisse. Ma si scoprirà che il sostituto, alla morte del parroco non ha tenuto fede a questo impegno ed ha utilizzato tutti i soldi per mettere su un orfanatrofio di bambine figlie della guerra, ossia di ragazze madri italiane e soldati occupanti. Uno smacco non solo economico, perché lei sperava con quella cifra di rifarsi una vita. La sostiene e guida nell’impresa una giovane spigliata che ha deciso di aggiungersi all’impresa incoraggiandola. ma la trasformazione di questa esperienza sarà anche emotiva spirituale; trovare lì nella sua isola, così visibilmente sul volto di queste bambine, il frutto di quel cedimento di quella umiliazione e di quella che la società, riteneva una colpa, neanche scontabile con l’intera vita.
Questa sapiente articolazione offerta dagli sceneggiatori e da Zampa, dei due piani di cronaca: della biografia di Agostina e quello sociologico, di quanto le guerre costruiscono e costituiscono tracce non solo di violenza ma anche di affetti e comunque umana empatia, ci risulta una sensibile analisi senz’altro condivisa.
Quelle bambine innocenti sono anche il frutto di momenti di solitudine umana, di giovani sperduti e incontratosi per destino nella violenza della guerra, che si sono aggrappati l’uno all’altro nelle loro giovani vite lanciate all’ignoto.
Da maestro i delicati ritratti, lo scorrere della camera sempre all’altezza dello sguardo, sono cammei quelle inquadrature di primissimi piani della Lollo, bellissima e il cui visino è associato con suggerimento pertinente e simbolico a quello delle bambine, orfanelle come lei. Sarà questo indizio di stile e di riprese che costituirà il nocciolo nella trasformazione del personaggio Agostina; rimasta innocente, come le bambine della Chiesa e nonostante il marchio sociale di prostituta, di donna senza moralità, finirà per riscattarsi dopo l’incontro e le parole del parroco, un magistrale Eduardo De filippo, che si prenderà tutte le colpe dell’imbroglio in punto di morte, solo per aver cercato di fare il bene di queste figlie della guerra.
Agostina comprende, in quel dialogo sobrio, e muto seppur segnato a commozione e lacrime che
anche lei è figlia della guerra e forse il giovane che la ama nonostante il suo passato è la vera ricchezza del suo presente; è sarà quel mare di nuovo a fare da separazione e ponte tra uomini e donne nei loro drammi e nelle loro speranze e nelle loro illusioni.
Il padrone sono me (1955) di Franco Brusati
Per guardare il film: https://www.youtube.com/watch?v=AIqNoKtZrfQ
La voce fuori campo di Vanni dirà, chiudendo gli occhi nell’ultimo sguardo morente di suo padre e guardando dalla finestra sulla spiaggia la ciurma di ragazzini che giocano festosi al pallone: “sono i padroni di domani, cresceranno e avranno dei figli, a loro volta illusi di possedere qualcosa sulla terra: Non posseggono nulla. Di tante lotte, passioni, irragionevoli amori non resterà che un gran silenzio, rotto soltanto dal respiro pacato del mare.”
È il tema della storia tratta da un romanzo di Alfredo Panzini. Un film tecnicamente da restaurare, certamente rivalutato. Ha molti pregi sommessi eppure capaci di tenere il filo della narrazione con una naturalezza tra la cronaca diretta e il ricordo biografico. È la genia e il giro delle generazioni che attraversano trasformazioni sociali pur restando strettamente legati ai sentimenti. Tanti temi si intrecciano: l’amicizia, la giovinezza, il conformismo sociale, la differenza di classe che vengono esposti in una sceneggiatura senza salti, sembra quasi un piano sequenza tra interni ed esterni credibili e suggestivi di un occhio estetico ma non lezioso.
Due o tre inquadrature fanno i nodi del film e il regista li ha saputi cogliere con sensibile sguardo. Il saluto alla stazione durante la partenza di Robertino diretto in guerra con una eccellente prospettiva drammatica, il primissimo piano della padrona di casa quando raccoglie l’ultimo respiro del marito caduto per terra colpito da un infarto e l’inquadratura totale del contadino divenuto padrone, un magnifico Paolo Stoppa, che seduto a una sedia padronale tiene il fucile fumante sulle ginocchia e dice al figlio: “ ho sparato per spaventarlo (ai guaiti del cane lasciato dalla padrona) perché ora deve ubbidire a me.” Anche le bestie cambieranno padrone e così la terra, una nuova classe si sta emancipando conservando virtuosamente il danaro frutto del proprio lavoro come una speranza di riscatto. I contadini sono ignoranti ma non stupidi ci viene da riflettere, e forse sono più vicini alla vita perché sono più vicini alla fatica per la sopravvivenza. Anche Dolly, la giovane compagna d’infanzia, in un certo senso sceglie di sopravvivere quando sposa il ricco industriale americano piuttosto che cedere all’amore incondizionato del giovane Robertino. Una dichiarazione d’amore senza mezze misure, là sulla spiaggia dell’Adriatico in un grigio ricco di una tavolozza che il direttore della fotografia riesce a spargere per tutto il film.Stesso impegno lodevole e ben riuscito è l’accompagnamento sonoro di Roman Vlad, il quale riesce a far mergere dalle molte pause, il colore dei suoi accenti del suo commento strumentalmente appropriato. Un rimando va a bernardo Bertolucci che deve aver apprezzato.
I temi delle generazioni contadine e borghesi che si intrecciano nelle trasformazioni sociali.
Un film dal costo contenuto e ben riuscito negli intenti narrativi volti all’esposizione anche con un tono filosofico sulla vita e sulla morte nel gran circolo sociale degli uomini e delle loro illusioni. Quel timbro di controluce che spesso si annoda nel corso della storia tra esterni notte ed esterni giorno finiscono per costruire l’atmosfera filmica con un proprio stile. Ne potremmo avere conferma con un restauro tecnico ora che il soggetto ha raccolto la nostra attenzione con la necessità di promuovere nel cinema un restauro anche morale, oggi, più che mai.
Cronaca di poveri amanti (19554) di Carlo Lizzani
Per vedere il film: https://www.youtube.com/watch?v=bJv9m8WWB5w
Il cinema della nostra tradizione narrativa che può ancora insegnarci qualcosa. E non si tratta dei temi o delle tragedie fratricide, seppure quelle costituiscono una spina nel nostro passato e una preoccupazione sempre vigile sul nostro presente. Qui sapientemente raccontato da un romanzo vibrante di Vasco Pratolini, scrittore autodidatta dalla vena linguistica mescolata tra l’italiano e il locale dialetto che in questo caso è il fiorentino. Il film apre con un narratore esterno, uno dei personaggi e come un piano sequenza della memoria lentamente entra con un lento carrello in Via del Corno. Gli amori che vi si intrecciano sono il mondo vibrante di questa via, il suo sangue pulsante, l’umanità conflittuale, negata, calpestata e resistente al male e allo steso tempo aperta, irrinunciabile al destino della propria storia. Tutto i protagonisti e i secondari sono credibili, convincenti e calati nella parte con indiscutibile naturalezza: Marcello Mastroianni, Anna Maria Ferrero, Antonella Lualdi. Riescono a tenere stretta una recitazione spontanea e neorealista benchè la presa del sonoro non sia in diretta, elemento di scelta non proprio neorealista ortodosso. La conduzione ha la povertà del titolo ma non manca nulla; ci sono tutte le scene che devono esserci con un taglio di inquadratura sapientemente centrato all’essenziale senza alcun indugio decorativo o inessenziale. A volte è quasi strutturata come un processo visivo sia morale che estetico. Una povertà di troupe e una povertà di set oggi difficile da concepire, eppure il risultato è efficace, stringente, convincente e noi lo seguiamo con il cuore pronto a commuoversi e con la mente pronta e cercarne le ragioni dei gesti delle condotte delle scelte che gli uomini compiono, dando voce a quell’umanità da cui non possiamo separarci.
Rigorosa e veritiera la fotografia riesce ad assumere un tono fortemente realistico e direi proprio di cronaca come per il titolo del romanzo. I tagli delle inquadrature i primi piani misurati ci rendono l’atmosfera di quegli anni rimescolando in noi sentimenti e ragioni e soprattutto indulgenza verso chi pur giovane non vedeva nel presente un domani per il proprio futuro se non nella lotta nella provvidenza talvolta e nella fuga da quella povertà impietosa o talvolta generosamente condivisa. È bello questo cinema fatto di elementi essenziali, senza troppi effetti edulcorati né omologate sintassi sceniche per una conduzione oggi imperante di cliché visivo e pubblicitario.
Quei volti così luminosi delle attrici protagoniste, la loro recitazione spontanea e convincente, sono per noi maggiore sollecitazione a rivalutare queste testimonianze del nostro cinema e riprenderne in mano la genia e l’insegnamento morale e estetico, senza che la povertà dei mezzi ci spaventi.
La Fuggitiva (1941) di Piero Ballerini
Per vedere il film:
https://www.youtube.com/watch?v=BJ57tJp77Ls
https://www.youtube.com/watch?v=BJ57tJp77Ls
Un film apparentemente sommesso, fuori da scuole, che sa farsi seguire con un sentimento costante e una sobrietà sintattica di visione.
Il titolo ben riuscito “La Fuggitiva” è rivolto alla giovanissima interprete Mariù Pascoli, la bambina, dal nome Marina nella storia, che fugge da casa per protestare contro lo zelo delle governanti e l’assenza troppo frequente del padre. La recitazione della piccina, seppure un poco impostata, riesce credibile emotivamente, e non è poco per quei tempi del cinema, non certo informali e disinvolti come quelli di oggi, sia nei costumi che nella psicologia sociale.
Nell’aria ingessata del clima austero che il soggetto ha previsto nella storia si dipana una sceneggiatura ben condotta, essenziale e ritmicamente giustificata dal corso degli eventi drammatici del copione. Il set che si articola negli stabilimenti cinematografici di Torino Fert ci può riportare alla memoria un cinema italiano che aveva sul proprio territorio tante risorse di produzione e di logistica. Si, è un prodotto confezionato nello stile del cinema della finzione-narrazione, e diciamo anche della traduzione distaccata dalla verità del mondo reale, eppure l’insieme, sia per la maturazione progressiva dei personaggi-protagonisti e sia per l’ambientazione cosi lontana dalla nostra attività frenetica, ci colpisce e procura tenerezza mista a nostalgia.
Jole Voleri, qui protagonista dotata di giusta misura, è in scena un’anima bella e come tale si comporta per tutta la storia.
Le disgrazie la mettono alla prova e nello stesso tempo la invitano a non cedere, a rialzarsi sempre e sperare alla felicità.
Si apre con un doppio matrimonio; ma si terrà solo quello in abito. Bianco, ricco e ordinario, mentre il suo, quello che l’avrebbe fatta sposa non si terrà. Il naufragio si scoprirà sarà stato un bene, visto l’interesse del suo fidanzato per i soldi del nonno di Delfina, benestante e ben disposto nei riguardi della nipote che invece è chiusa in un risentimento famigliare doloroso. I suoi genitori artisti sono morti in povertà per la durezza di cuore e la disapprovazione del vecchio nei riguardi della scelta che la figlia aveva fatto fuori dalle aspettative sociali della famiglia. Non solo a sua madre, ora anche a Delfina, sembra, che il destino abbia riservato una serie di prove; qui, nella sua storia, il fidanzato è un’artista ma presto emerge il suo opportunismo d’interesse per il denaro, mentre il padre di Marina, l’ingegnere Antonio in fine l’amerà solo perse stessa.
Jole Voleri. è una attrice che ci ha lasciato pochi film, anche se ha avuto una lunga vita; in queste prove è molto convincente, conferendo al personaggio una indovinata delicatezza di carattere e una nostalgia per quella trasparenza d’animo, di cui la
bambina fuggitiva ne è immediatamente conquistata.
Il titolo ben riuscito “La Fuggitiva” è rivolto alla giovanissima interprete Mariù Pascoli, la bambina, dal nome Marina nella storia, che fugge da casa per protestare contro lo zelo delle governanti e l’assenza troppo frequente del padre. La recitazione della piccina, seppure un poco impostata, riesce credibile emotivamente, e non è poco per quei tempi del cinema, non certo informali e disinvolti come quelli di oggi, sia nei costumi che nella psicologia sociale.
Nell’aria ingessata del clima austero che il soggetto ha previsto nella storia si dipana una sceneggiatura ben condotta, essenziale e ritmicamente giustificata dal corso degli eventi drammatici del copione. Il set che si articola negli stabilimenti cinematografici di Torino Fert ci può riportare alla memoria un cinema italiano che aveva sul proprio territorio tante risorse di produzione e di logistica. Si, è un prodotto confezionato nello stile del cinema della finzione-narrazione, e diciamo anche della traduzione distaccata dalla verità del mondo reale, eppure l’insieme, sia per la maturazione progressiva dei personaggi-protagonisti e sia per l’ambientazione cosi lontana dalla nostra attività frenetica, ci colpisce e procura tenerezza mista a nostalgia.
Jole Voleri, qui protagonista dotata di giusta misura, è in scena un’anima bella e come tale si comporta per tutta la storia.
Le disgrazie la mettono alla prova e nello stesso tempo la invitano a non cedere, a rialzarsi sempre e sperare alla felicità.
Si apre con un doppio matrimonio; ma si terrà solo quello in abito. Bianco, ricco e ordinario, mentre il suo, quello che l’avrebbe fatta sposa non si terrà. Il naufragio si scoprirà sarà stato un bene, visto l’interesse del suo fidanzato per i soldi del nonno di Delfina, benestante e ben disposto nei riguardi della nipote che invece è chiusa in un risentimento famigliare doloroso. I suoi genitori artisti sono morti in povertà per la durezza di cuore e la disapprovazione del vecchio nei riguardi della scelta che la figlia aveva fatto fuori dalle aspettative sociali della famiglia. Non solo a sua madre, ora anche a Delfina, sembra, che il destino abbia riservato una serie di prove; qui, nella sua storia, il fidanzato è un’artista ma presto emerge il suo opportunismo d’interesse per il denaro, mentre il padre di Marina, l’ingegnere Antonio in fine l’amerà solo perse stessa.
Jole Voleri. è una attrice che ci ha lasciato pochi film, anche se ha avuto una lunga vita; in queste prove è molto convincente, conferendo al personaggio una indovinata delicatezza di carattere e una nostalgia per quella trasparenza d’animo, di cui la
bambina fuggitiva ne è immediatamente conquistata.
Cuore forestiero (1952) di Armando Fizzarotti
Un film cartolina con una storia esile, un dramma sentimentale e un sonoro che accompagna le immagini come una partitura della finzione dell’opera; le esagerazioni della sceneggiatura, molto prevedibile e forse con troppi raccordi di tempi e di coperture dei cambi narrazione. I protagonisti, Maria (Maria Piazzai) e Armando (Piero Lulli), recitano dignitosamente a volte con un accenno un poco teatrale ma autenticamente calati nella parte. Gli esterni della città fotografano una Napoli che non c’è più, per quanto il suo pittoresco cielo e mare siano in primo piano, oggi, anche questi due protagonisti della cartolina e del costume popolare hanno un altro colore, più digitale e meno
evanescente nella sua nuvola paesaggistica e melodica.
Il soggetto di Antonio Ferrigno, che ne è anche il produttore del film, ci induce a una non frequente presenza di doppia collaborazione: artistica ed economica; in questo genere, forse, troveremo, facendo ricerca, un filone interessante su alcuni aspetti produttivi di un certo cinema italiano.
Nella sceneggiatura ci sembra di scorgere una vicenda “Cuore”, quelle narrazioni deamicisiane che hanno tanto influito nella formazione dei giovani italiani del primo novecento. Il ritorno a Napoli del protagonista dopo anni di vita in America e che ci viene raccontato in prima persona è un motivo abbastanza comune nel costume della città Pertenopea. Il protagonista è colto non solo dal dolore per la morte dell’amata ma anche da un rimorso di non averle creduto e di non essere stato capace di affrontare con coraggio le circostanze e le difficoltà della loro vita.
C’è un’aria di fotoromanzo, ( neorealismo d’appendice o strappalacrime nel termine più popolare), che mi spinge alla memoria giornaletti tanto in voga negli anni sessanta/settanta, intensi momenti contestatari delle forme e dei linguaggi dell’arte che oggi guardiamo a volte con nostalgia.
Gli attori protagonisti e le volanti comparse girano intorno al tema con mimetico accento di recitazione, tra la noncurante lentezza dialettale e una lingua italiana commerciale senza accenti, senza sottolineature letterarie. Molte inquadrature un poco stereotipate fanno da raccordo ai tempi della storia: eros, innamoramento, promessa, trasgressione, litigio, inganno, amicizia, tradimento, rinuncia, pentimento, morte. E qui emergono nelle vicende umane sentimenti che sono propri della nostra specie, come il rimorso; un desiderio, dolore tra passato e presente, che ci tiene sospesi all’impossibilità di rimediare a una scelta già compiuta, eppure viviamo quel desiderio con una intensità che ci fa scoppiare il cuore dal petto.
La narrazione è al maschile, ma il dramma e la tragedia è al femminile; è la donna che dovrà soccombere all’inganno che gli uomini le hanno causato, e lo farà non solo con l’uscita dal mondo ma con la lenta negazione del suo stesso corpo, spegnendosi di crepacuore; copertura medico letteraria per dire che è morta di dolore. Lei che aveva avuto salva la vita, cresciuta da una zia, e dalla parente protetta e educata ad entrare nel mondo con il matrimonio e la protezione sociale della vita coniugale. La caduta morale è troppo cocente e non se la sentirà di ricorrere alla consolazione dell’anziana donna; ho apprezzato di non essere ricorsi alla facile soluzione della visita di questa al capezzale della nipote morente, che pure sembrava naturale, cadenza e caduta del film.
Misuratamente, ma un poco salvifico, il film viene chiuso con un totale su Armando che, dopo l’inquadratura della grata della prigione, dove ha è confessato il marinaio il suo delitto e complicità nell’inganno perpetrato ai due giovani fidanzati, attraverso una dissolvenza ci riporta al protagonista, mentre sale la scala del cimitero, risoluto a deporre un mazzo di fiori sulla tomba dell’amata sfortunata.
Persiane chiuse (1950) di Luigi Comencini
Per vedere il film:
https://www.youtube.com/watch?v=Tzc836afooM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=Tzc836afooM&t=15s
Comencini ci chiama a un cinema verità con una vena investigativa del cinema americano. Siamo negli anni cinquanta e la stagione neorealista matura è compiuta.
Ora si può puntare la messa a fuoco e zoomare sui protagonisti per descriverne il progressivo intimo disorientamento e l’inadeguatezza ai cambiamenti violenti che si stanno insinuando nel tessuto sociale.
A guerra finita la comunità non è stata capace di riprendersi in una parità comprensiva dei più deboli, dei più vulnerabili e violati.
Il film ha una sintassi ben articolata con giuste sequenze nella loro durata drammatica e descrittiva ed è ben disegnato il ritmo delle inquadrature magistralmente sorrette da un accompagnamento sonoro di grande efficacia emotiva.
La Rossi Drago è profondamente nella parte e ha sfumature di recitazione che ricordano la Bergman. È sicura sia nei primi piani che nelle azioni; è il personaggio che fa le indagini in un mondo malavitoso, perché vi è caduta sua sorella (Liliana Gerace); è il punto più audace del soggetto.
La credibilità a volte stenta ma poi tutto sommato ne accogliamo la finzione come compromesso ad aver seguìto, fin dall’apertura, una storia di omicidi, di sfruttamento e di violenza nel quotidiano lacerato di città italiane, povere, piene di conflitti e
contraddizioni e non certo il regno della criminalità delle big band americane.
Reggiamo la lenta penetrazione e discesa in quel mondo di piccola malavita quando nel progressivo svilupparsi della storia emerge il tema: un amore tra sorelle.
E per quanto un poco spinto nell’ottimismo ne siamo coinvolti e parteggiamo per la riuscita della salvezza, anche perché non solo Sandra ne è il personaggio positivo ma anche Lucia, la minore perduta è personaggio positivo e destinato al riscatto dell’amore
filiale con il ritorno a casa; inquadratura finale della storia, in un totale spezzato da alcuni primi piani di dialogo muto ma profondamente espressivo nel suo lieto fine.
L’affresco sul femminile emerge con compiutezza verso la fine con la retata delle donne che fanno la vita e portate in caserma vengono rinchiuse in cella.
Qui i movimenti-camera sanno descriverci sia i singoli volti che la solidarietà dell’insieme corale di queste umiliate e sfruttate, rimbrottate dagli stessi agenti di polizia come se la loro miseria ne diminuisse la dignità umana.
I pani ripresa scavano talvolta in un naturalismo che sa esprimere il paesaggio umano di facce e di destini; storie misere di cui i soggetti sono incolpevoli, e così le ragazze e le donne dell’orfanotrofio dove la protagonista si recherà invano per cercare la sorella.
I locali notturni, le bettole e i bar costituiscono un itinerario penoso e formativo per la giovane donna che fa da ponte e filo affettivo con la famiglia modesta nella provincia piemontese, e dalla quale Lucia è scappata con il malavitoso giovine che si fa chiamare “Primavera”(Renato Baldini).
Ora si può puntare la messa a fuoco e zoomare sui protagonisti per descriverne il progressivo intimo disorientamento e l’inadeguatezza ai cambiamenti violenti che si stanno insinuando nel tessuto sociale.
A guerra finita la comunità non è stata capace di riprendersi in una parità comprensiva dei più deboli, dei più vulnerabili e violati.
Il film ha una sintassi ben articolata con giuste sequenze nella loro durata drammatica e descrittiva ed è ben disegnato il ritmo delle inquadrature magistralmente sorrette da un accompagnamento sonoro di grande efficacia emotiva.
La Rossi Drago è profondamente nella parte e ha sfumature di recitazione che ricordano la Bergman. È sicura sia nei primi piani che nelle azioni; è il personaggio che fa le indagini in un mondo malavitoso, perché vi è caduta sua sorella (Liliana Gerace); è il punto più audace del soggetto.
La credibilità a volte stenta ma poi tutto sommato ne accogliamo la finzione come compromesso ad aver seguìto, fin dall’apertura, una storia di omicidi, di sfruttamento e di violenza nel quotidiano lacerato di città italiane, povere, piene di conflitti e
contraddizioni e non certo il regno della criminalità delle big band americane.
Reggiamo la lenta penetrazione e discesa in quel mondo di piccola malavita quando nel progressivo svilupparsi della storia emerge il tema: un amore tra sorelle.
E per quanto un poco spinto nell’ottimismo ne siamo coinvolti e parteggiamo per la riuscita della salvezza, anche perché non solo Sandra ne è il personaggio positivo ma anche Lucia, la minore perduta è personaggio positivo e destinato al riscatto dell’amore
filiale con il ritorno a casa; inquadratura finale della storia, in un totale spezzato da alcuni primi piani di dialogo muto ma profondamente espressivo nel suo lieto fine.
L’affresco sul femminile emerge con compiutezza verso la fine con la retata delle donne che fanno la vita e portate in caserma vengono rinchiuse in cella.
Qui i movimenti-camera sanno descriverci sia i singoli volti che la solidarietà dell’insieme corale di queste umiliate e sfruttate, rimbrottate dagli stessi agenti di polizia come se la loro miseria ne diminuisse la dignità umana.
I pani ripresa scavano talvolta in un naturalismo che sa esprimere il paesaggio umano di facce e di destini; storie misere di cui i soggetti sono incolpevoli, e così le ragazze e le donne dell’orfanotrofio dove la protagonista si recherà invano per cercare la sorella.
I locali notturni, le bettole e i bar costituiscono un itinerario penoso e formativo per la giovane donna che fa da ponte e filo affettivo con la famiglia modesta nella provincia piemontese, e dalla quale Lucia è scappata con il malavitoso giovine che si fa chiamare “Primavera”(Renato Baldini).
Preludio d’amore (1946) di Giovanni Paolucci
Per vedere il film:
https://www.youtube.com/watchv=E63gpleWB8k&t=21s
https://www.youtube.com/watchv=E63gpleWB8k&t=21s
Genova, Camogli, porto pidocchio è l’ambientazione del film; il mare è protagonista, anche se in battute riflesse portate dai personaggi a metà tra la vita reale e a metà nella finzione del cinema. Il soggetto semplice e credibile ci ricorda la immodificabile triangolazione dell’attesa nell’amore di chi è partito e nella speranza di chi è rimasto. E qui la guerra ha tenuto lontano il giovane Davide, un giovanissimo e talentuoso Vittorio Gassman, figlio di pescatore che ritorna a Camogli con il desiderio di sentire suonare le campane di San Prospero, segno di fedeltà alla promessa d’amore osservata da lui e spera anche dalla sua ragazza.
Le sequenze degli esterni, nella luce del mare con i suoi riflessi naturalistici, ci raccontano da vicino le prove di un riaccendersi dei sensi e dei sentimenti, ingarbugliati e mescolati ad azioni malavitose di cui è portatore Rocco, anch’egli giovanissimo e talentuoso Massimo Girotti, un marinaio di barche private che si è corrotto con la piccola criminalità locale.
La storia dei furti di gioielli si intreccia alla storia delle due ragazze che si contendono più nella forma che nella sostanza il giovane marinaio del pontile ora invaghitosi di Anna dopo aver liquidata Tea, l’ex fidanzata.
La giovane Anna, una splendida Marina Berti, giovanissima, fidanzata del marinaio appena ritornato dal conflitto bellico, dopo 4 anni di assenza, ha avuto momenti difficili, con la morte della madre. Lascia intendere che ha dovuto trovare modo per sopravvivere; e non è stato facile, ritrovandosi sola, senza la protezione di un uomo, mentre la sorella più piccola, Laura (Vira Silenti), ha preso i voti e ha riparato nel convento del Paese.
I primi piani e molti dettagli di associazione simbolica sanno restituirci, in un montaggio ritmico e con giuste accelerazioni, quell’atmosfera del mare, il vento salato e il calore delle guance delle due protagoniste.
Tentativi iconici riusciti sono cosparsi qui e là nella sceneggiatura: l’antro delle barche, dove i pescatori riparano le reti, gli scorci dei carruggi in Genova presso il porto, le inquadrature dei palazzi trapuntati di persiane e donne e bambini che si sporgono curiosi verso il mondo, che va per il suo corso a volte anche tragico.
Ci viene suggerito con una progressione emotiva nella sequenza finale, in cui Davide giunge appena in tempo ad evitare un delitto che stava assumendo i caratteri di un rito espiatorio, oltre che una vendetta sollecitata dai bassi istinti della folla, dalla sua perdita di senno e dignità.
Qui i gruppi di comparse, le masse popolari si iscrivono da parte dell’autore negli intenti di una critica sociale ai costumi e alle tradizioni di quelle comunità di mare, che infondo non sa giustificare la miseria di quegli ambienti, di quei protagonisti.
E certamente una pellicola che merita un restauro, che testimonia di un momento intenso del cinema italiano condotto da produzioni avventurose ma sensibili. E se anche sono visibili standard più bassi o inaccettabili per il cinema di oggi, la fotografia, il sonoro, riescono comunque a dare un’impronta onesta di ricerca nella vita reale delle contraddizioni di costume sociale e dei suoi conflitti.
Apprezziamo la progressione sia psicologica dei personaggi che la capacità sintattica di costruire il dramma di scena, i conflitti a due e i contesti corali come l’ultimo magistrale del tentativo di linciaggio di Anna.
Vera sensibile lettura della follia della folla quando cerca un capro espiatorio e si coinvolge alla violenza a un sacrificio di sangue, dopo aver isolata la vittima ed esclusa dal contesto della comunità. Non si avvedono, purtroppo, della loro stessa miseria,
dell’innocenza della vittima designata, e della loro perdita di empatia, di umanità.
La barca che avanza vogata da Davide, verso il piccolo porticciolo degli anziani pescatori, dediti alla riparazione delle reti, dove il padre del giovane marinaio attende il ritorno del figliol prodigo, è una efficace e misurata chiusura simbolica e scenica del film; ora la salvezza per i due giovani è nella speranza, nell’opportunità di un destino ricongiunto che custodisca il loro amore.
Le sequenze degli esterni, nella luce del mare con i suoi riflessi naturalistici, ci raccontano da vicino le prove di un riaccendersi dei sensi e dei sentimenti, ingarbugliati e mescolati ad azioni malavitose di cui è portatore Rocco, anch’egli giovanissimo e talentuoso Massimo Girotti, un marinaio di barche private che si è corrotto con la piccola criminalità locale.
La storia dei furti di gioielli si intreccia alla storia delle due ragazze che si contendono più nella forma che nella sostanza il giovane marinaio del pontile ora invaghitosi di Anna dopo aver liquidata Tea, l’ex fidanzata.
La giovane Anna, una splendida Marina Berti, giovanissima, fidanzata del marinaio appena ritornato dal conflitto bellico, dopo 4 anni di assenza, ha avuto momenti difficili, con la morte della madre. Lascia intendere che ha dovuto trovare modo per sopravvivere; e non è stato facile, ritrovandosi sola, senza la protezione di un uomo, mentre la sorella più piccola, Laura (Vira Silenti), ha preso i voti e ha riparato nel convento del Paese.
I primi piani e molti dettagli di associazione simbolica sanno restituirci, in un montaggio ritmico e con giuste accelerazioni, quell’atmosfera del mare, il vento salato e il calore delle guance delle due protagoniste.
Tentativi iconici riusciti sono cosparsi qui e là nella sceneggiatura: l’antro delle barche, dove i pescatori riparano le reti, gli scorci dei carruggi in Genova presso il porto, le inquadrature dei palazzi trapuntati di persiane e donne e bambini che si sporgono curiosi verso il mondo, che va per il suo corso a volte anche tragico.
Ci viene suggerito con una progressione emotiva nella sequenza finale, in cui Davide giunge appena in tempo ad evitare un delitto che stava assumendo i caratteri di un rito espiatorio, oltre che una vendetta sollecitata dai bassi istinti della folla, dalla sua perdita di senno e dignità.
Qui i gruppi di comparse, le masse popolari si iscrivono da parte dell’autore negli intenti di una critica sociale ai costumi e alle tradizioni di quelle comunità di mare, che infondo non sa giustificare la miseria di quegli ambienti, di quei protagonisti.
E certamente una pellicola che merita un restauro, che testimonia di un momento intenso del cinema italiano condotto da produzioni avventurose ma sensibili. E se anche sono visibili standard più bassi o inaccettabili per il cinema di oggi, la fotografia, il sonoro, riescono comunque a dare un’impronta onesta di ricerca nella vita reale delle contraddizioni di costume sociale e dei suoi conflitti.
Apprezziamo la progressione sia psicologica dei personaggi che la capacità sintattica di costruire il dramma di scena, i conflitti a due e i contesti corali come l’ultimo magistrale del tentativo di linciaggio di Anna.
Vera sensibile lettura della follia della folla quando cerca un capro espiatorio e si coinvolge alla violenza a un sacrificio di sangue, dopo aver isolata la vittima ed esclusa dal contesto della comunità. Non si avvedono, purtroppo, della loro stessa miseria,
dell’innocenza della vittima designata, e della loro perdita di empatia, di umanità.
La barca che avanza vogata da Davide, verso il piccolo porticciolo degli anziani pescatori, dediti alla riparazione delle reti, dove il padre del giovane marinaio attende il ritorno del figliol prodigo, è una efficace e misurata chiusura simbolica e scenica del film; ora la salvezza per i due giovani è nella speranza, nell’opportunità di un destino ricongiunto che custodisca il loro amore.
Sotto il sole di Roma (1948) di Renato Castellani
Per vedere il film:
Il realismo magico del cinema italiano è pienamente compiuto in questa opera di Castellani, che è autore del soggetto assieme a Fausto Tozzi.
Un’apertura che sembra di commedia volge con crescente sapienza e sensibilità al dramma; un soggetto che è uno spaccato di verità, con degli attori credibili e di talento tutti. È quel cinema di sceneggiatura che rende le battute e i cambi così naturali da non sembrare neanche cinema ma indiscreta osservazione o anche confidenziale narrazione di fatti e personaggi reali. E ciò è dovuto non solo alla essenzialità dell’italiano misto al dialetto romano quanto alla stringatezza delle inquadrature sia esterne che interne, in una sintassi di stacchi veloci e di forti primi piani riuscitissimi non divistici ma espressivi delle dinamiche del racconto.
Un amore rimosso quanto più vulcanico e inascoltato di Ciro e Iris (Liliana Mancini); una sedicenne che pur senza formazione attoriale è fortemente incisiva e calata nel personaggio con una vitalità e una maturità che è già da donna, e un volto di forte carica espressiva. Castellani ne aveva saputo cogliere le potenzialità, quando fu fermata in strada, e scelta per il film.
La loro apparente ingenuità è così disarmante oggi, che ci sembrano iscritti in una fiaba, benché il clima di guerra connoti tutto il tempo del film. Il sacrificio della genitorialità per i propri figli è una chiave immediata senza alcun giudizio morale né retorica; tutto si compie nella sua naturalezza, il machismo infantile di Ciro, la disapprovazione materna quanto l’amore silenzioso e negato di Iris, le scorribande pericolose con la compagnia-ciurma dei compagni di quartiere; il destino di tanti ragazzi e giovani che in quegli anni di stenti mettevano alla prova la resistenza di una condotta onesta e solidale. Avventurosi perlustratori di periferie della città nelle incursioni al corso d’acqua la “Marrana” e nei monumenti silenti come il Colosseo dove tra le millenarie pietre vi trovano rifugiato un “senzafamiglia”, raccoglitore di cicche di tabacco, il Geppa, già noto “Antonio” di Miracolo a Milano.
Non è difficile leggere in alcuni passaggi una lezione chapliniana e quei set esterni della città di Roma ci riconducono più volte al “Monello” prototipo del disadattato che cerca di tenersi a galla dalla miseria e l’ingiustizia o anche semplicemente dal destino avverso.
La fotografia (Domenico Scala) è una pennellata di realismo, con spunti di reportage più che di effetti speciali, e riesce a introdurci ulteriormente nella verità del contesto sociale ma soprattutto nella verità dei protagonisti, che emergono dallo schermo come fossero nostri affettivi conoscenti.
Non c’è spazio per scene inutili o didascaliche, merito degli autori di talento (Renato Castellani, Sergio Amidei, Emilio Cecchi, Ettore Margadonna, Fausto Tozzi), anche il materiale simbolico è scarno e funzionale alla drammaticità del racconto circolare; racconto che ci viene narrato in soggettiva da Ciro, (Oscar Blanco) come raggiunta autocritica della sua coscienza e della raggiunta maturità in quel mondo dove annegare e perdersi è un attimo.
Commovente l’amore di Iris (Liliana Mancini) per Ciro; ci riempie il cuore perché vero e nonostante le mascalzonate del giovane le sue gonfiate affermazioni di superiorità e di autonomia; finzioni alle quali ben presto lui stesso non crederà, ma non è facile uscire da un modello sociale anche se si ha buona volontà. Sarà la tragedia a chiedergli il conto; prima la morte di sua madre, di crepacuore, quando ha creduto che i tedeschi lo avevano portato via, e in epilogo, con la morte del padre, guardia notturna, ucciso dai suoi compagni di piccola malavita, scoperti a rubare le gomme da un deposito. Infine dovrà mettere la testa sulle spalle e sfamare tre fratelli più piccoli riportando in equilibrio la catena dorata dell’amore, forse annunciata in quella croce pendente da una catenina al collo di Iris fin dalle prime uscite di scena; ecco un altro simbolo là sotto gli occhi ma proprio per questo vero e naturale, efficace all’intera drammaturgia.
In questo film c’ero dentro fino al collo quasi per tutto il suo svolgimento: la vita domestica con le battute lanciate, il lavoro notturno del capofamiglia, i fratelli piccoli, la mamma esasperata, la ragazza del pianerottolo, la ciurma dei compagni, le bravate, le fughe sul tram e dai più vari inseguitori se no truffati irrisi, gabbati da improperi goliardici; non c’era la guerra nella mia infanzia e giovinezza, o almeno non la miseria ma un subdolo, lento, comunque processo d’insidia del relativismo morale dei sentimenti e dei doveri, della onestà del cuore e del dire.
Un paesaggio umano che certo non vogliamo idealizzare ma nemmeno rimuovere, dimenticare, capace di suscitarci una nostalgia critica sia per il linguaggio asciutto e onesto del cinema che per i contenuti sociali, la forza umana del credere in un futuro, anche senza tanti sproloqui, senza profuse teorie. E su questa innocenza del vivere che Pasolini comprenderà la inevitabile fine del ceto proletario, la cui unica ricchezza per un secolo sono stati appunto i figli.
Va dato grande merito in questa storia la capacità degli autori di far recitare i ragazzini e i giovani con una estrema naturalezza da evitargli quell’imbellettamento dell’inquadratura e della finzione scenica che riduce il pathos visivo e la scorrevolezza della narrazione. Nella sceneggiatura circolare il film si apre con l’entrata in inquadratura del padre di Ciro che torna a casa dal turno di notte della sorveglianza e si chiude con Ciro che torna a casa con un pugno di spaghetti sfusi a peso che si comprava in quegli anni. E fin dall’inizio lo svolgimento delle giornate assolate della capitale, che a cielo aperto mostra alcuni squarci del quartiere della Basilica di San Giovanni, del Colosseo, la storia è contrappuntata dal commento musicale di Nino Rota, (diretto da Franco Ferrara) che in quegli anni, giovanissimo, matura la sua esperienza di talento, componendo per quest’opera filmica un credibile doppio lato dell’emozioni sia nel verso commedia che nel verso dramma. Tempi in cui la produzione cercava le sue etichette con un tono internazionale come qui appare nei tipi dell’ “Universalcine”.
Nel corso di una formazione alla crescita della propria maturità i due protagonisti si fronteggiano, si respingono, si attraggono in una ambientazione difficile, di stenti ma anche di incoscienza e goliardia, presente nella drammaturgia di alcuni momenti scenici chiave e significativi, come: la scena della restituzione del denaro nello sterrato del quartiere, la scena notturna del furto al deposito delle gomme Pirelli, dove il padre di Ciro perderà la vita.
È una prova di stima, questa narrazione del cinema italiano, per le donne o quelle donne che ne sanno più e prima dell’amore, perché sperimentano sul proprio corpo e sul proprio cuore quanto “Tutto è sotto il sole, il duro giorno della vita.”
Il realismo magico del cinema italiano è pienamente compiuto in questa opera di Castellani, che è autore del soggetto assieme a Fausto Tozzi.
Un’apertura che sembra di commedia volge con crescente sapienza e sensibilità al dramma; un soggetto che è uno spaccato di verità, con degli attori credibili e di talento tutti. È quel cinema di sceneggiatura che rende le battute e i cambi così naturali da non sembrare neanche cinema ma indiscreta osservazione o anche confidenziale narrazione di fatti e personaggi reali. E ciò è dovuto non solo alla essenzialità dell’italiano misto al dialetto romano quanto alla stringatezza delle inquadrature sia esterne che interne, in una sintassi di stacchi veloci e di forti primi piani riuscitissimi non divistici ma espressivi delle dinamiche del racconto.
Un amore rimosso quanto più vulcanico e inascoltato di Ciro e Iris (Liliana Mancini); una sedicenne che pur senza formazione attoriale è fortemente incisiva e calata nel personaggio con una vitalità e una maturità che è già da donna, e un volto di forte carica espressiva. Castellani ne aveva saputo cogliere le potenzialità, quando fu fermata in strada, e scelta per il film.
La loro apparente ingenuità è così disarmante oggi, che ci sembrano iscritti in una fiaba, benché il clima di guerra connoti tutto il tempo del film. Il sacrificio della genitorialità per i propri figli è una chiave immediata senza alcun giudizio morale né retorica; tutto si compie nella sua naturalezza, il machismo infantile di Ciro, la disapprovazione materna quanto l’amore silenzioso e negato di Iris, le scorribande pericolose con la compagnia-ciurma dei compagni di quartiere; il destino di tanti ragazzi e giovani che in quegli anni di stenti mettevano alla prova la resistenza di una condotta onesta e solidale. Avventurosi perlustratori di periferie della città nelle incursioni al corso d’acqua la “Marrana” e nei monumenti silenti come il Colosseo dove tra le millenarie pietre vi trovano rifugiato un “senzafamiglia”, raccoglitore di cicche di tabacco, il Geppa, già noto “Antonio” di Miracolo a Milano.
Non è difficile leggere in alcuni passaggi una lezione chapliniana e quei set esterni della città di Roma ci riconducono più volte al “Monello” prototipo del disadattato che cerca di tenersi a galla dalla miseria e l’ingiustizia o anche semplicemente dal destino avverso.
La fotografia (Domenico Scala) è una pennellata di realismo, con spunti di reportage più che di effetti speciali, e riesce a introdurci ulteriormente nella verità del contesto sociale ma soprattutto nella verità dei protagonisti, che emergono dallo schermo come fossero nostri affettivi conoscenti.
Non c’è spazio per scene inutili o didascaliche, merito degli autori di talento (Renato Castellani, Sergio Amidei, Emilio Cecchi, Ettore Margadonna, Fausto Tozzi), anche il materiale simbolico è scarno e funzionale alla drammaticità del racconto circolare; racconto che ci viene narrato in soggettiva da Ciro, (Oscar Blanco) come raggiunta autocritica della sua coscienza e della raggiunta maturità in quel mondo dove annegare e perdersi è un attimo.
Commovente l’amore di Iris (Liliana Mancini) per Ciro; ci riempie il cuore perché vero e nonostante le mascalzonate del giovane le sue gonfiate affermazioni di superiorità e di autonomia; finzioni alle quali ben presto lui stesso non crederà, ma non è facile uscire da un modello sociale anche se si ha buona volontà. Sarà la tragedia a chiedergli il conto; prima la morte di sua madre, di crepacuore, quando ha creduto che i tedeschi lo avevano portato via, e in epilogo, con la morte del padre, guardia notturna, ucciso dai suoi compagni di piccola malavita, scoperti a rubare le gomme da un deposito. Infine dovrà mettere la testa sulle spalle e sfamare tre fratelli più piccoli riportando in equilibrio la catena dorata dell’amore, forse annunciata in quella croce pendente da una catenina al collo di Iris fin dalle prime uscite di scena; ecco un altro simbolo là sotto gli occhi ma proprio per questo vero e naturale, efficace all’intera drammaturgia.
In questo film c’ero dentro fino al collo quasi per tutto il suo svolgimento: la vita domestica con le battute lanciate, il lavoro notturno del capofamiglia, i fratelli piccoli, la mamma esasperata, la ragazza del pianerottolo, la ciurma dei compagni, le bravate, le fughe sul tram e dai più vari inseguitori se no truffati irrisi, gabbati da improperi goliardici; non c’era la guerra nella mia infanzia e giovinezza, o almeno non la miseria ma un subdolo, lento, comunque processo d’insidia del relativismo morale dei sentimenti e dei doveri, della onestà del cuore e del dire.
Un paesaggio umano che certo non vogliamo idealizzare ma nemmeno rimuovere, dimenticare, capace di suscitarci una nostalgia critica sia per il linguaggio asciutto e onesto del cinema che per i contenuti sociali, la forza umana del credere in un futuro, anche senza tanti sproloqui, senza profuse teorie. E su questa innocenza del vivere che Pasolini comprenderà la inevitabile fine del ceto proletario, la cui unica ricchezza per un secolo sono stati appunto i figli.
Va dato grande merito in questa storia la capacità degli autori di far recitare i ragazzini e i giovani con una estrema naturalezza da evitargli quell’imbellettamento dell’inquadratura e della finzione scenica che riduce il pathos visivo e la scorrevolezza della narrazione. Nella sceneggiatura circolare il film si apre con l’entrata in inquadratura del padre di Ciro che torna a casa dal turno di notte della sorveglianza e si chiude con Ciro che torna a casa con un pugno di spaghetti sfusi a peso che si comprava in quegli anni. E fin dall’inizio lo svolgimento delle giornate assolate della capitale, che a cielo aperto mostra alcuni squarci del quartiere della Basilica di San Giovanni, del Colosseo, la storia è contrappuntata dal commento musicale di Nino Rota, (diretto da Franco Ferrara) che in quegli anni, giovanissimo, matura la sua esperienza di talento, componendo per quest’opera filmica un credibile doppio lato dell’emozioni sia nel verso commedia che nel verso dramma. Tempi in cui la produzione cercava le sue etichette con un tono internazionale come qui appare nei tipi dell’ “Universalcine”.
Nel corso di una formazione alla crescita della propria maturità i due protagonisti si fronteggiano, si respingono, si attraggono in una ambientazione difficile, di stenti ma anche di incoscienza e goliardia, presente nella drammaturgia di alcuni momenti scenici chiave e significativi, come: la scena della restituzione del denaro nello sterrato del quartiere, la scena notturna del furto al deposito delle gomme Pirelli, dove il padre di Ciro perderà la vita.
È una prova di stima, questa narrazione del cinema italiano, per le donne o quelle donne che ne sanno più e prima dell’amore, perché sperimentano sul proprio corpo e sul proprio cuore quanto “Tutto è sotto il sole, il duro giorno della vita.”
Pietà per chi cade (1954) di Mario Costa
Per vedere il film;
Primi piani da cinema intessuti da un commento sonoro drammaticamente efficace sorreggono tutta la storia. Una sceneggiatura circolare elegantemente amplifica il soggetto del tradimento coniugale, illustrandone la tragica svolta, dopo un insperato ricongiungimento avvenuto al termine di una guerra che li aveva separati. Anna Savelli e suo marito Carlo Savelli sono entrambi protagonisti resi credibilissimi nella recitazione di Amedeo Nazzari e Nadia Gray.
Le inquadrature di apertura e di chiusura sul treno, prima in arrivo, poi in epilogo in partenza, rendono il senso della distanza e del ritorno, pur nella loro immagine tecnologicamente antiquata; anzi queste ambientazioni d’esterni e alcune macchine delle comunicazioni e da viaggio ci sollecitano a una riflessione su un passato che è oggi: nostalgia, per noi non giovanissimi, e curiosità se poco più che ventenni. Il soggetto è nel dramma psicologico di un amore extraconiugale, vissuto dalla donna assieme alla speranza del ritorno del marito, più per sfuggire ad una solitudine e alla nevrosi, che per un travolgimento di passione. È troppo giovane e bella, Anna, la protagonista per chiudersi in una prigione da vedova, dopo otto anni di attesa del suo uomo dato disperso. Le attenuanti sembrano emergere a soccorso per tutti i protagonisti, meno per l’amante che viene dipinto come chi non vuole tirarsi indietro, neanche dinnanzi alla dichiarata verità di essere scelto, per secondo, nel cuore di una benestante signora borghese di origine veneta.
La caduta della donna travolge in quanto danno anche la figlia (Antonella Lualdi) che fino a quel momento di rivelazione drammatica viveva nella sua sfera di sogni giovanili e speranze artistiche, essendo una pianista di talento. È la crisi della famiglia borghese senza colpe, benché ci sia nell’ordine degli sviluppi psicologici un omicidio; il delitto giustificato dell’adulterio, o almeno alleggerito da attenuanti sociali e comportamentali; i personaggi a questo punto vengono tutti ricondotti a un lieto fine, certo ritagliato su misura, forse per volontà produttive, o anche per allineamento al costume legislativo, poiché il delitto per onore godeva di comprensione nella società di quegli anni cinquanta.
Tutto precipita quando, Bianca, la figlia dei due protagonisti si lascia sedurre dal maestro di musica, Livio Vanini (Massimo Serato) che, mosso anche dal desiderio di possederla, la coinvolge nel suo calendario di concerti per violino, proponendosi in un repertorio a due con il pianoforte.
Sono due donne, madre e figlia, che si confrontano sull’amore; la bellezza di entrambe ce le rende vicine, proviamo a capire i loro punti di vista, non dimenticando, né rimuovendo l’offesa, il tradimento di un uomo, un padre che, nella storia non sembra avere molti torti, anzi ci viene raccontato come il personaggio positivo, risparmiato dalla guerra e neanche imbruttito o vinto. È stato lontano dalla vita che scorre, dalla vita dei sensi, quei sensi che hanno convinto lei, nei suoi desideri di donna di accogliere un’altra seduzione, un amore vivo e presente. Può beneficiare di qualche attenuante, la figlia da crescere e che ora è una giovane donna piena di entusiasmi e talenti. La mancanza del padre non ne ha diminuito la tempra, la disciplina. Eppure con la scoperta dell’adulterio della madre, lei, Bianca, crolla, svanisce quell’identificazione di un amore morale per fare emergere l’incontrollabilità dei sensi che la condurrà per disperazione, autopunizione, identificazione con la madre, tra le braccia del maestro Vanini, pronto a sedurla più per iniziarla all’eros che per farne preda o compagna di vita, tanto meno una moglie, visto che è già sposato.
Il film, dal tono romanzato e condotto da Mario Costa, un regista dalle incursioni nel cinema del teatro d’opera, ha una sceneggiatura a più mani (tra cui Anton Giulio Majano, autore del soggetto “La Barriera” e Tullio Pinelli co-sceneggiatore) che risulta omogenea con un ritmo senza vuoti e una chiusura drammatica credibile.
La fotografia (Anchise Brizzi) ha dei bei neri e primi piani intensi; gli esterni (tranne Firenze che è un fondale), molto realistici, soprattutto della stazione, le calli di Venezia, i canali, rafforzano la storia e conferiscono quella verità di narrazione drammatica che è di molto cinema italiano di quegli anni.
Le inquadrature di apertura con il commento sonoro di Rustichelli sono un vero e proprio esempio di introduzione drammatica, con poche note e un totale campo lungo del treno che sta per entrare nella stazione di Venezia. Il tema, poi, si distende con una voce melodica sostenuta dagli archi che lentamente prendono tutta la scena, e così via, il personaggio Carlo comincia il suo ritorno a casa.
Dopo poche sequenze si consuma l’omicidio con un intreccio temporale che va tra il passato e il presente; il film si avvia a sondare nel nostro cuore e nella nostra mente le forme di empatia e di giudizio per la storia a cui ci viene chiesto di partecipare e condividere il dramma. Non è facile prendere posizione in quanto i personaggi sono descritti tutti in positivo, solo Vanini ci viene dipinto senza morale ingannatore, e la sorella di Anna, della protagonista, colpevole di aver nascosto a suo cognato la verità sui sentimenti ancora vivi, l’immutato amore di sua moglie per lui.
E in questo modo il delitto si trasformerà in tragico incidente, e financo la corte si schiererà per questa versione, graziando, l’imputato a 4 anni di reclusione; ma sarà la moglie, addossandosi tutte le colpe di adultera, ad aumentare le attenuanti del gesto di Carlo.
I dialoghi, le battute e i fuori campo sono tutti puntuali con qualche screzio nel doppiaggio a volte non perfetto nel sincrono per le voci femminili.
La folle corsa di Bianca che salva la madre da un suicidio certo in quel luogo di transito che sono le stazioni ferroviarie ci indica la recuperata identità e perdono delle protagoniste. Un primo piano delle due donne piangenti, guancia a guancia, si consolano e ci consolano; scampate al pericolo al delitto morale, alla giustificazione della clemenza sull’omicidio a danno dell’amante, un soggetto perturbatore esterno ai ruoli e agli equilibri sociali: la famiglia è salva. Almeno nella possibilità di ritentare una rinascita dopo la catarsi.